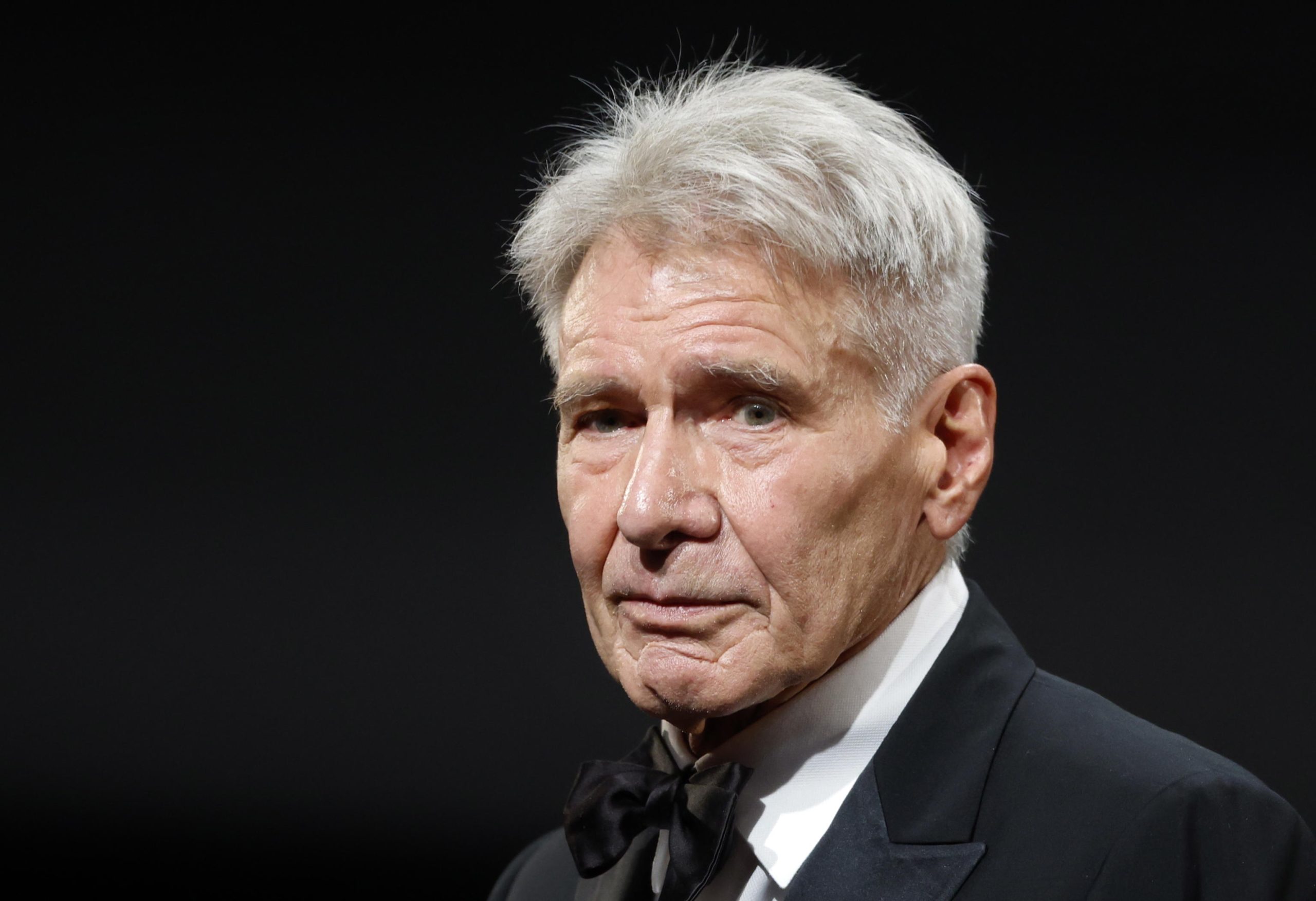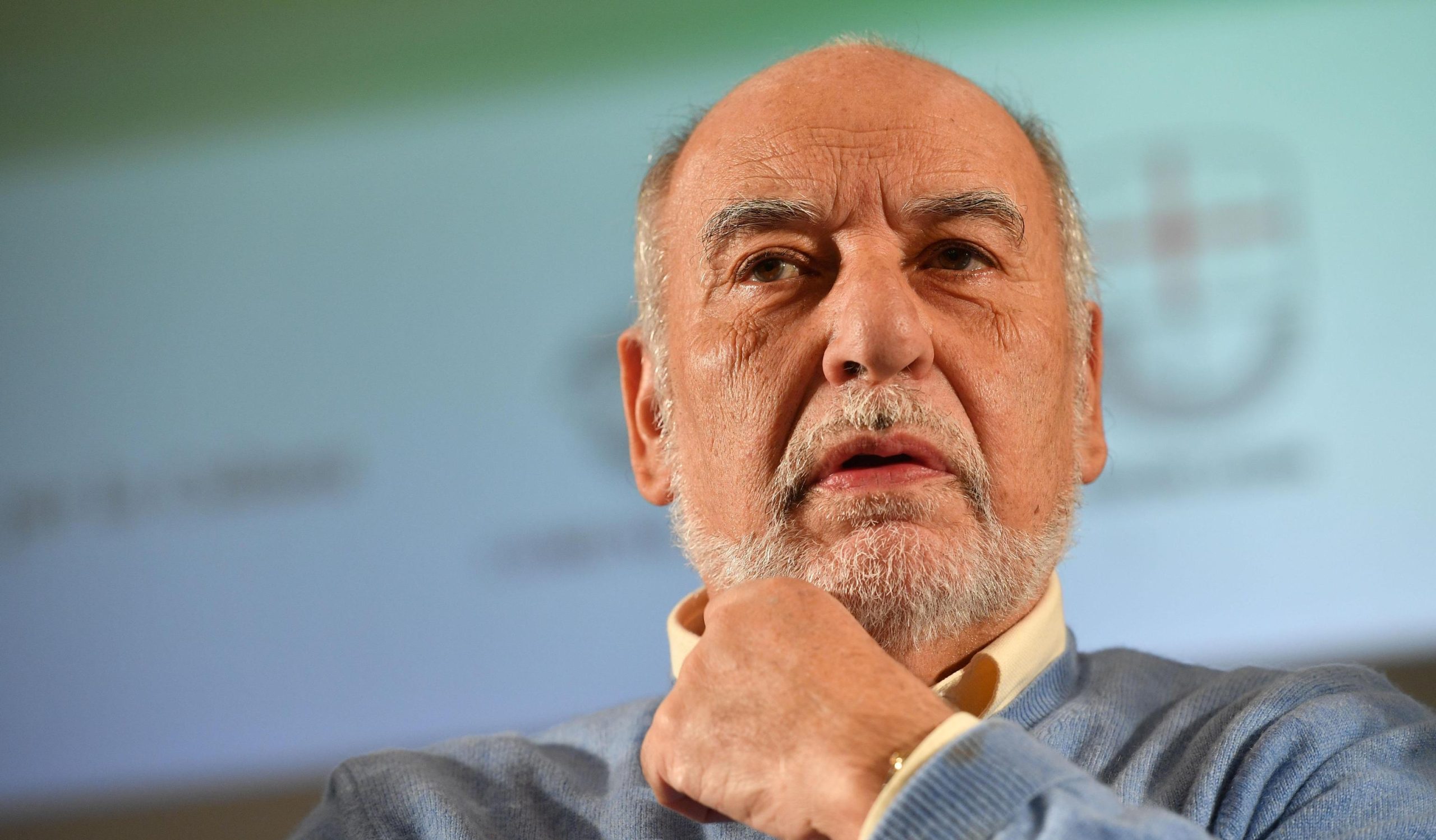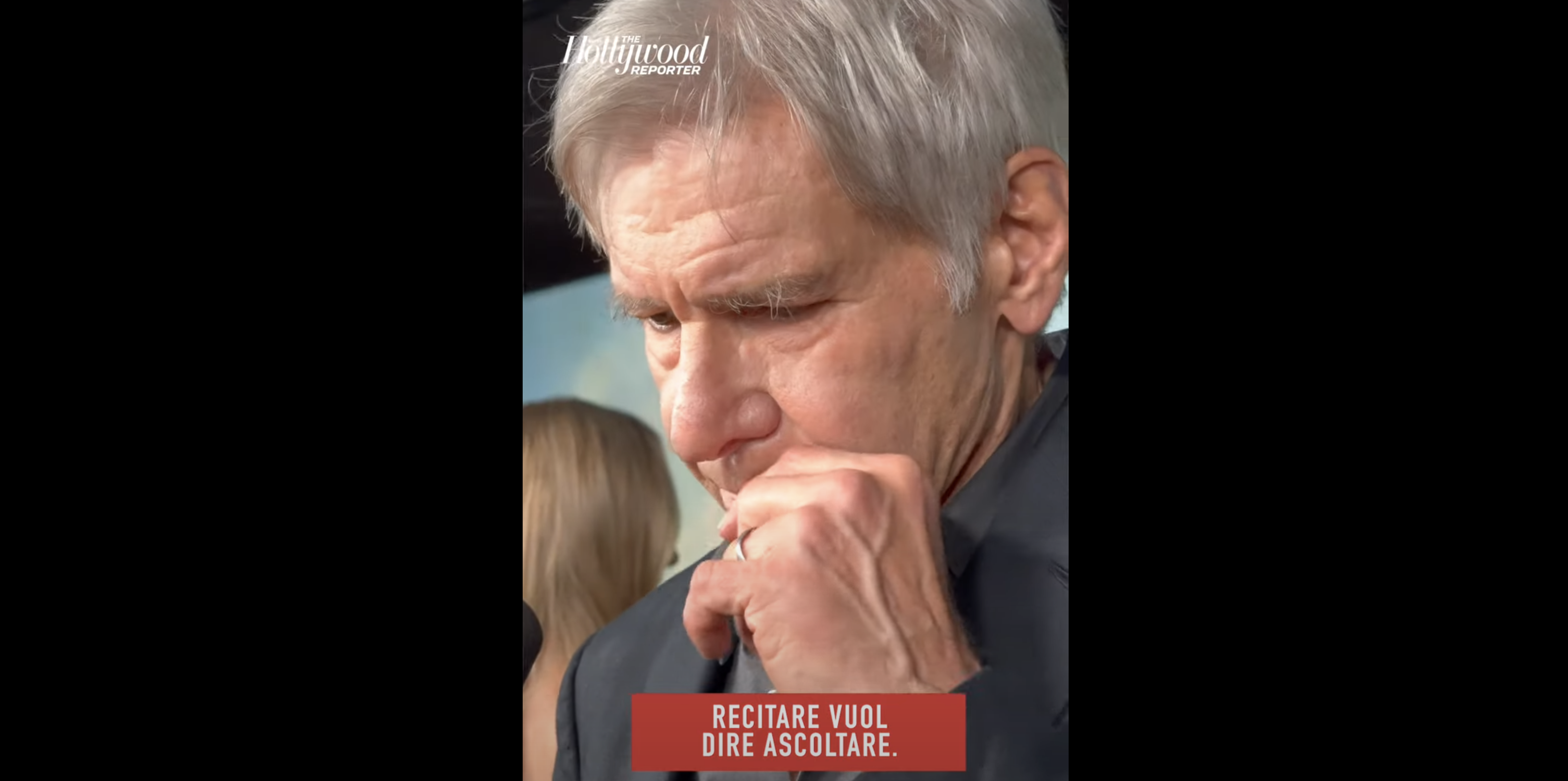Negli anni Settanta la cappa del muro di Berlino, della guerra fredda e della separazione della Germania tra il blocco occidentale e quello sovietico hanno fortemente pesato sull’industria cinematografica nazionale di quegli anni. Se a Est si ricordano pochi film quasi tutti di propaganda per il regime, a Ovest il cinema tedesco produce per il mercato internazionale soprattutto i film del cosiddetto Junger Dutscher Film, il nuovo cinema tedesco.
È un cinema profondamente innovativo che nasce a inizio anni Sessanta sull’onda delle Nouvelle Vague di tutto il mondo e prende corpo nel manifesto di Oberhausen per una nuova cinematografia nazionale, firmato nel 1962 dagli allora sconosciuti Edgar Reitz e Alexander Kluge. Sulla sua scia si sono poi schierati Jean-Marie Straub, Rainer Fassbinder, Werner Herzog e di fatto anche Wim Wenders, tutti autori che proprio negli anni Settanta raggiungono la loro notorietà internazionale.
Questo cinema era pensato, ideato e distribuito per un pubblico intellettuale e trovava la sua naturale collocazione nelle sale d’essai, facendo anche numeri molto importante (i film di Wenders, di Herzog e di Fassbinder sono stati campioni di incasso) ma caratterizzandosi proprio in contrapposizione con il cinema commerciale (quello che il manifesto di Oberhausen definiva proprio “cinema di papà”, decretandone la morte).
I fari erano tutti accesi su queste produzioni tralasciando completamente il cinema di genere, per il quale in Germania vi era una certa tradizione (giustamente il curatore della Cineteca tedesca Rainer Rother sottolinea che in Germania, negli anni Venti, sono di fatto nati alcuni generi importanti come l’horror e la fantascienza con le opere di Lang, di Wiene, di Murnau…).
Ebbene, è proprio Rother a curare alla Berlinale la retrospettiva sul cinema commerciale tedesco di quegli anni, che il titolo da lui scelto definisce: “Selvaggio, strano, sanguinolento”.
Eh sì, il cinema di quegli anni era proprio così, lo sappiamo anche per quanto riguarda l’Italia, la Spagna e altre cinematografie che hanno prodotto in quel decennio film popolari che hanno avuto più fortuna dei loro coevi germanici.
C’era molto sesso nei film commerciali tedeschi, con un vero e proprio star system un po’ noto anche da noi (la più conosciuta era Terry Torday, attrice ungherese che ha interpretato “la casta Susanna” in almeno cinque film usciti anche in Italia, ma c’era spazio anche per una giovanissima Edvige Fenech con film dal titolo italiano diventato leggendario (“Alle dame del castello piace molto fare quello”, ad esempio), usciti dopo il suo successo italiano, prima con i gialli e poi con le commedie sexy.
E per quanto riguarda il sangue, la presenza è altrettanto forte. Come sappiamo, nel decennio precedente in Germania si erano specializzati nei “crimi”, noir in bianco e nero più o meno ispirati alle opere di Edgar Wallace (La porta delle sette chiavi) e spesso coprodotti con Italia e/o Spagna). Dopo la svolta impressa al thriller prima da Mario Bava e poi soprattutto da Dario Argento, anche i tedeschi accentuano il carattere “forte” delle scene dei loro thriller.
Se Lady Dracula (con Brad Harris, già uno dei Maciste nella stagione d’oro del mitologico italiano) mescola una struttura da horror tradizionale con battute e situazioni sexy tipiche del periodo, La tenerezza del lupo di Ulli Lommel propone la vicenda di un serial killer assetato di sangue con immagini che ricordano i film espressionisti di Fritz Lang.
Per quanto riguarda la componente ‘stranezza’, c’è solo l’imbarazzo della scelta, con un western psichedelico ambientato nel deserto, una donna che va a fare una vacanza in America con il neosposo e si trova invischiata in una vicenda di trafficanti di organi, performances veramente estreme da parte di sconosciuti gruppi rock germanici. Insomma, un viaggio in un cinema recente ma decisamente sconosciuto, che ha riservato non poche sorprese.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma