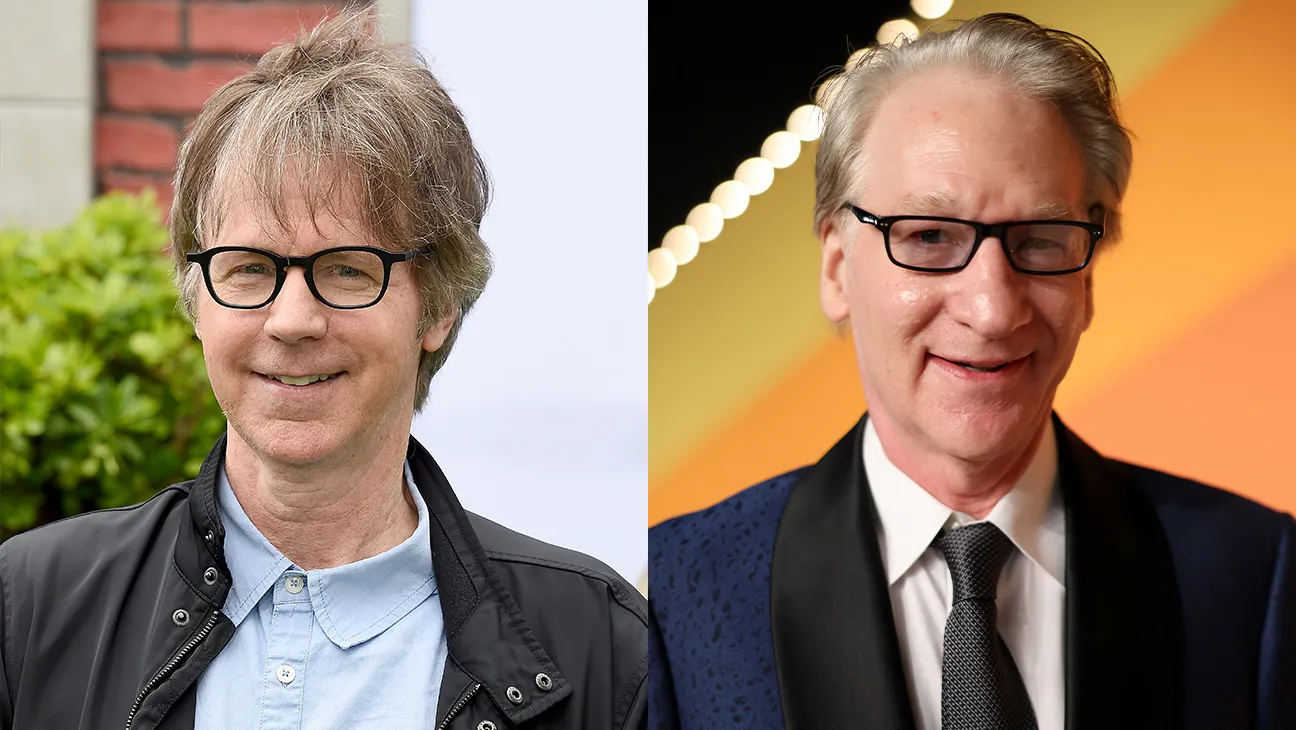Alle Scuderie del Quirinale, fino al 13 luglio, si può attraversare un mondo che non si sfoglia nei manuali di storia dell’arte, ma si ascolta con l’intelligenza di chi sa che Roma non è mai stata solo Roma. Barocco globale è una mostra potente, stratificata, colta, ma anche sorprendentemente attuale. Curata da Francesca Cappelletti e Francesco Freddolini e realizzata in collaborazione con la Galleria Borghese, l’esposizione interroga il Seicento romano non come epoca cristallizzata, ma come centro dinamico di scambi, tensioni e visioni. Un momento storico in cui la città dei papi era anche città del mondo, nodo di una rete invisibile ma concreta fatta di ambascerie, missioni, mercanti, oggetti e sguardi.
Il racconto comincia con un volto, quello dell’ambasciatore congolese Antonio Manuel Ne Vunda, arrivato a Roma nel 1608 dopo un lungo e drammatico viaggio, e morto poco dopo. Il suo busto, scolpito da Francesco Caporale e custodito nella Basilica di Santa Maria Maggiore, è stato restaurato da Ales S.p.A. con un intervento illuminato, che non si è limitato alla conservazione fisica, ma ha riattivato la memoria e la presenza di una figura centrale nel disegno papale di universalità. Ne Vunda non è più un nome dimenticato: il suo volto in marmi policromi è la chiave di lettura di tutta la mostra, il simbolo di una Roma che si apriva all’altro senza rinunciare a definirlo secondo i propri canoni, ma riconoscendolo.
Le opere non sono disposte per scuole o per nomi, ma per costellazioni di senso. Si passa da Bernini a mappe, da reliquiari mesoamericani a miniature indiane, da bozzetti monumentali a ritratti diplomatici. L’allestimento accompagna e mai impone. Le luci scolpiscono. Il risultato è un percorso immersivo senza bisogno di artifici.
Il viaggio visivo inizia con la sezione dedicata all’Africa e all’Egitto, dove l’alterità non è un’esotizzazione, ma un’occasione di riflessione sull’identità. Il Giovane africano di Cordier e il Cesare che rimette Cleopatra sul trono di Pietro da Cortona dialogano con le culture che evocano. La figura nera non è relegata a sfondo o allegoria, ma parte integrante del discorso figurativo barocco.

Roma, Scuderie del Quirinale, Mostra Barocco Globale @photocredit Scuderie del Quirinale
Poi arriva Bernini. Ma non il Bernini da copertina. Il focus è sulla Fontana dei Quattro Fiumi, e in particolare sul monumentale bozzetto esposto, proveniente dalla collezione Forti Bernini. La trasformazione della figura del Rio della Plata, inizialmente pensata con tratti amerindi e poi ripensata con tratti africani, racconta molto più di una scelta stilistica. È una presa d’atto che le Americhe, nel Seicento, erano già mondi contaminati, popolati da corpi deportati, da storie imposte. Bernini, da artista globale, lo intuisce e lo dice con la forma.
“La Chiesa e il Mondo” è forse il cuore teorico della mostra. Qui la propaganda missionaria si fa arte, e l’arte si fa mediazione. Icone cinesi della Salus Populi Romani, una Santa Cecilia miniata alla corte Mughal, il Ritratto di Nicolas Trigault in abiti cinesi: ogni opera racconta come l’immagine si adatti, si pieghi, si traduca. Il cattolicesimo non esporta solo dogmi, ma anche modelli visivi, adattati ai contesti locali. È un’arte che sa cedere, che sa negoziare.
La sezione sulla diplomazia globale è un esercizio di finezza curatoriale. Il ritratto di Ali-qoli Beg, ambasciatore persiano dipinto da Lavinia Fontana, e il catafalco per la moglie persiana di Pietro della Valle, raccontano la Roma delle ambascerie, dei funerali solenni, delle messe in scena pubbliche.
“Collezionare il Mondo” ci riporta alla Roma dei musei prima dei musei. La mitra piumata di San Carlo Borromeo, donata da Papa Pio IV, è un esempio vertiginoso: un oggetto liturgico profondamente europeo, ma fatto con materiali mesoamericani. Qui non c’è appropriazione, c’è sincretismo. Le cose non sono semplicemente portate a Roma: sono rielaborate, integrate, trasformate in significato.
La sezione più letteraria è forse quella sull’alterità nella mitologia e nella letteratura. Andromeda di Manetti è una principessa etiope immaginata come una Venere bionda. Il Guerriero orientale di Mola guarda lo spettatore con fierezza e mistero. La Maria Mancini Armida mette in scena un travestimento che è anche una performance di identità. Ogni quadro diventa domanda: chi guarda chi? E da dove?
Il finale è tutto per i viaggiatori. Robert Shirley e Teresia Sampsonia, ritratti da Anthony Van Dyck, sono la coppia simbolo della Roma barocca come città globale. Due ritratti splendidi, mai visti prima in Italia, prestati dal National Trust inglese. E poi Annibale che attraversa le Alpi di Poussin: un quadro enigmatico, con l’elefante Don Diego, venuto dall’India e diventato leggenda urbana.
La mostra si estende oltre le Scuderie, con le visite speciali agli affreschi del Quirinale, dove tra il 1616 e il 1617 furono rappresentati ambasciatori provenienti da tutto il mondo, ricevuti da Paolo V. È una tappa simbolica che fa da cornice a un racconto che non finisce sulle pareti del museo.
Barocco globale non è una mostra sul barocco. È una mostra sul mondo, che parte da Roma e arriva ovunque.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma