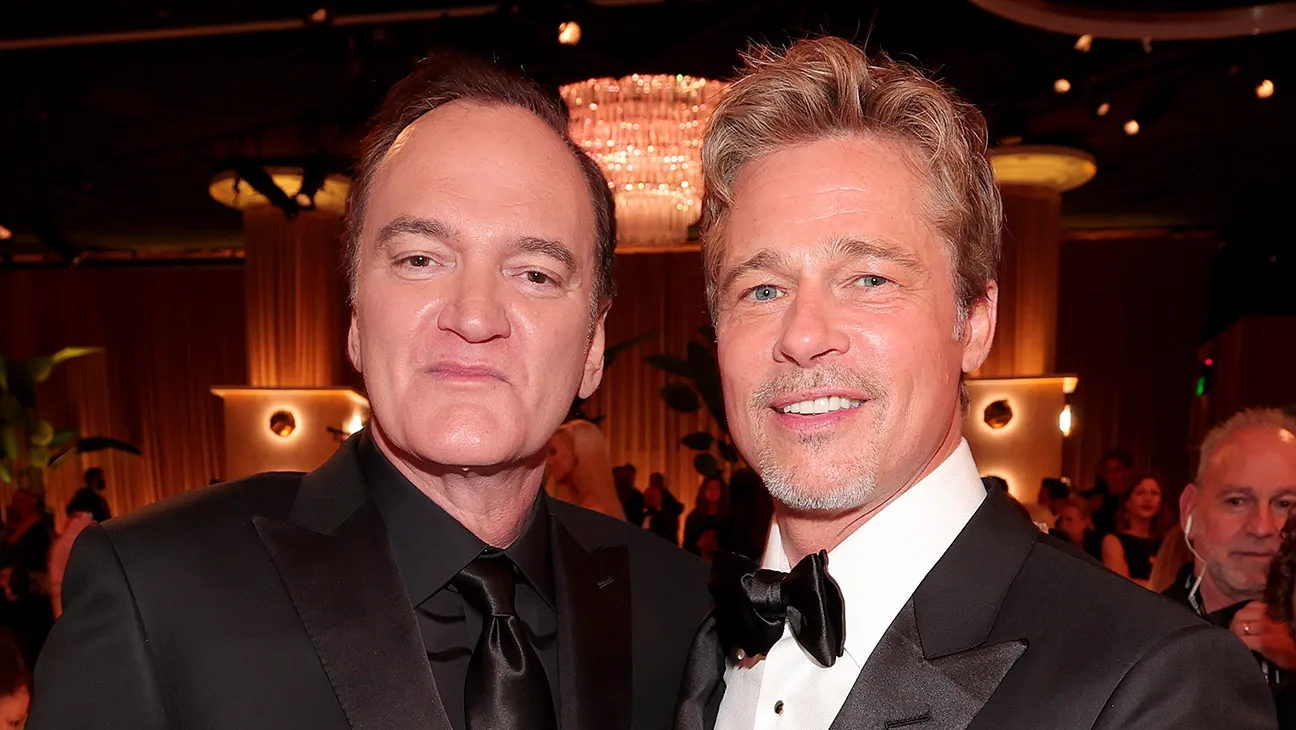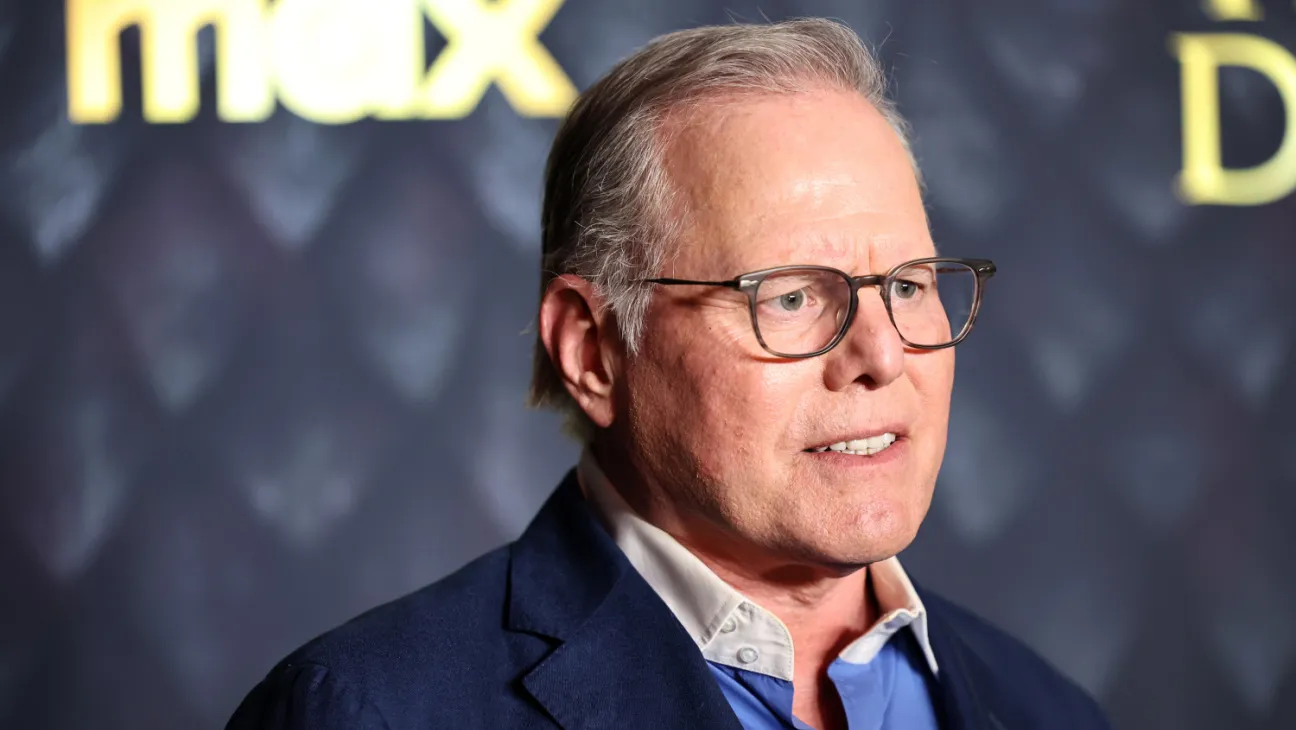Ha avuto inizio oggi la prima edizione del festival Custodi di sogni, della Cineteca Nazionale. Una giornata che ha portato insieme intellettuali e cineasti, giovani studenti e appassionati della settima arte, nel luogo che è cuore dell’industria. Il primo appuntamento, Immaginario e immaginari: L’io e il noi, ha segnato le tracce del percorso della rassegna. Mario Sesti ha moderato l’incontro con Costanza Quatriglio, documentarista, e Luca Ricciardi, archivista. Due “polarità” del mondo delle immagini: chi crea e inventa, chi conserva e osserva.
Una chiacchierata che ha saputo squarciare la quarta parete in poco tempo, con analisi suggestive del rapporto tra immagine e testo, e tra immagine e immaginario collettivo. Partendo dal documentario Terramatta, l’autrice, Quatriglio, ha raccontato la sua esperienza nel confrontarsi con due archivi ben diversi: quello letterario, il diario semianalfabeta di Vincenzo Rabito, e quello dell’audiovisivo. “Raccontava cose che non erano mai state filmate”: da qui, la necessità di “provocare immagini nello spettatore che non esistono sullo schermo”.
Un effetto Kulešov che si nutre di un procedimento fondamentale: l’aspetto ludico.
“Bisogna giocare con le immagini. Non c’è nulla di preordinato; si nasce dal fare”, ha ribadito Quatriglio.
Le parole chiave della conversazione sono state infatti “visibile” e “invisibile”. Un inizio simbolico che si è arricchito ulteriormente, quando si è parlato di 87 ore.
Altra opera della documentarista che, servendosi di nove videocamere di sorveglianza in un ospedale psichiatrico, ha saputo inquadrare proprio ciò che le immagini nascondono.
Ricordando la montatrice, nonché amica, recentemente scomparsa, Letizia Caudullo, Quatriglio ha invitato il pubblico a riflettere sul valore probatorio delle immagini o, meglio, a riflettere sulla pretesa delle immagini “di farci vedere tutto, perché quell’immagine non è altro che un frammento di un discorso più ampio che solo attraverso il montaggio si può disvelare.”
Il massimo della visibilità diventa, paradossalmente, il massimo dell’invisibilità.
E sembra più attuale che mai la necessità di interrogare le immagini, cercando quello spazio che non è stato inquadrato e che resta confinato all’invisibile. Proprio come lo studio della luce deve soffermarsi sulle ombre e sul buio: se la verità si trova nel non detto, il nostro compito è di ricomporre il non visto.
Nella Sala Pietro Germi sono stati poi proiettati i cortometraggi restaurati della Cineteca Griffith, che festeggia quest’anno il suo cinquantenario. Tra le opere, doveroso menzionare il primo documentario di Gillo Pontecorvo, Porta Portese, un luogo di “sogni interminabili… ma i sogni si sa non vanno a equilibrare le bilance…”.
Ed ecco la terza parola chiave della giornata e della rassegna stessa: “riuso”. La menzioniamo proprio qui, perché nel mercato romano domenicale “quasi si vergognano a vendere cose nuove, il mercato vero è quello della roba usata”.
La sala Pietro Germi riserba sorprese. Fu proprio qui che il regista Luca Verdone frequentò le lezioni di Roberto Rossellini e Sergio Leone. Ne ha parlato, tra aneddoti e sguardi nostalgici, prima di presentare il documentario dedicato al padre, Omaggio a Mario Verdone: tra arte e cinema.
“È un’emozione indicibile essere qui tra queste mura”, ha commentato Verdone. “Mio padre quando era il responsabile della Cineteca e Vicedirettore del Centro Sperimentale, mi portava sempre con sé, soprattutto nel periodo estivo. Dai dodici, tredici anni io ero sempre qui. Giocavo a basket nel campetto e andavo a curiosare nel teatro di posa. Ricordo bene di aver spiato Sergio Leone che girava. C’era una volta il West…”
L’incontro ha visto anche la produttrice, Laurentina Guidotti, amica della famiglia Verdone dall’infanzia.
Da ex allieva del Centro Sperimentale, ha raccontato la sua esperienza. “Ho ricevuto il mio diploma in quest’aula”, ha affermato, ricordando con entusiasmo le lezioni di Beppe De Santis e gli incontri con star dal calibro di Monica Vitti e Barbara Streisand.
La prima giornata si è chiusa a Spazio Scena, nel centro di Trastevere. La proiezione del restauro del documentario del 1978 di Claudio Caligari e Franco Barbero, La parte bassa, è stata un’occasione per riflettere sulle esigenze dei giovani, ma anche un’occasione per ridere di gusto, riscoprendo un regista scomparso troppo presto, che l’ironia ce l’aveva nel sangue. Steve Della Casa ha moderato l’incontro con Maurizio Calvesi, Maurizio Tedesco, Simone Isola, Giorgio Tirabassi e Nicola Guaglianone. “Un regista spiazzante”, lo ha definito Tirabassi; “Voleva Franco Nero in Non essere cattivo. Gli ho detto, Ma che gli facciamo fare a Franco Nero? Gli ho proposto Little Tony e gli è piaciuto”, ha commentato Tedesco.
“Claudio Caligari aveva un’intera parete di cassette con tutte le puntate registrate di Fuori Orario. Mi ha insegnato l’amore che bisogna avere per i personaggi, anche per quelli negativi. Li ha sempre raccontati con grande ironia”, ha ricordato Guaglianone, aggiungendo, “Ed era un esperto totale, soprattutto di criminalità. Mi raccontava che, quando in un tessuto sociale entra un nuovo tipo di droga, lo cambia per sempre. Faceva l’esempio di quando la cocaina ha sostituito l’eroina nelle borgate. E da quel momento in poi è morto il proletariato così come lo definiva Pasolini. Nel finale di Amore tossico, Cesare va a morire proprio dove è stato ammazzato Pasolini e dove c’è un destino immodificabile.
Ormai quel proletariato è finito. L’eroina viene sostituita dalla cocaina e la cocaina porta il sogno borghese”. La proiezione conclusiva è stata Amore Tossico, il film più acclamato del regista.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma