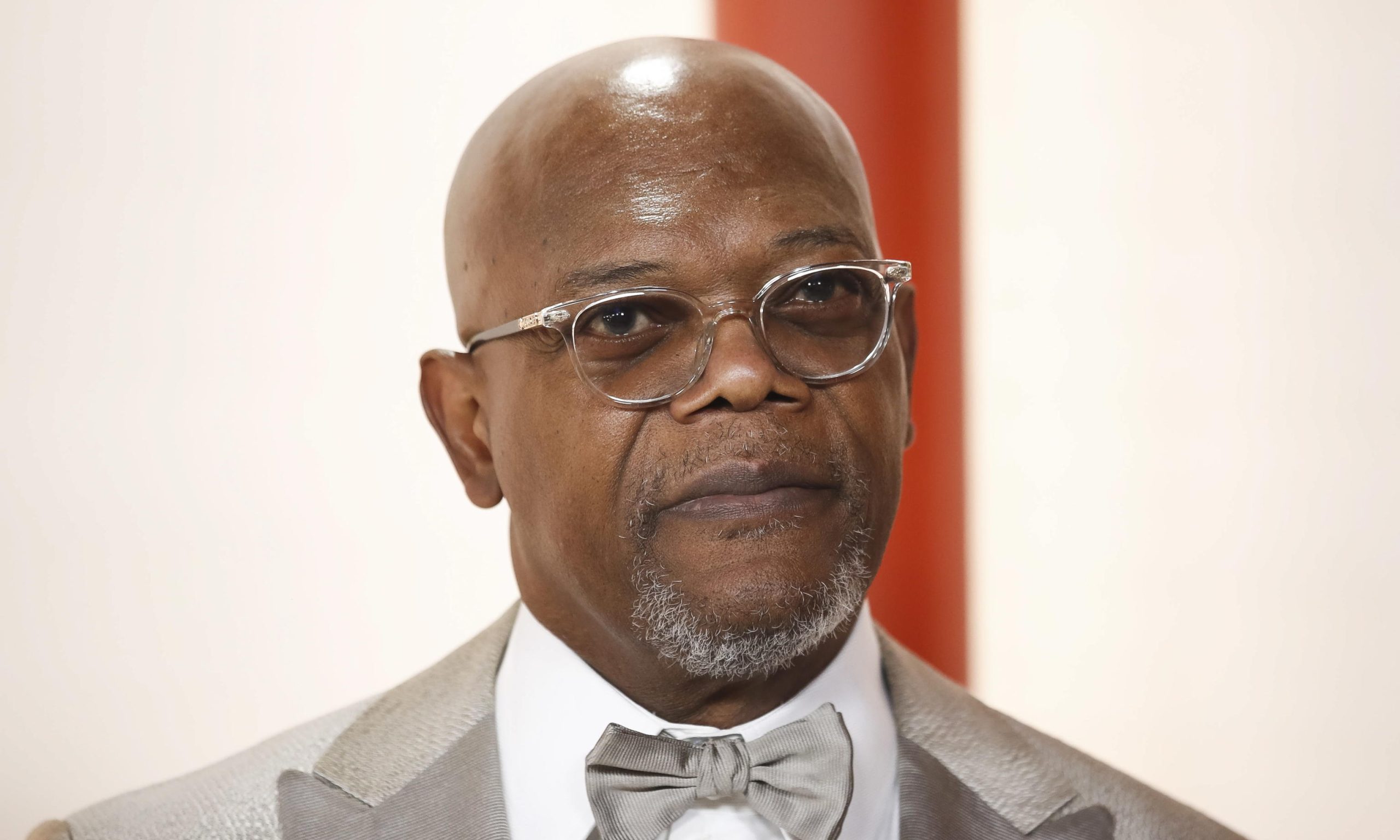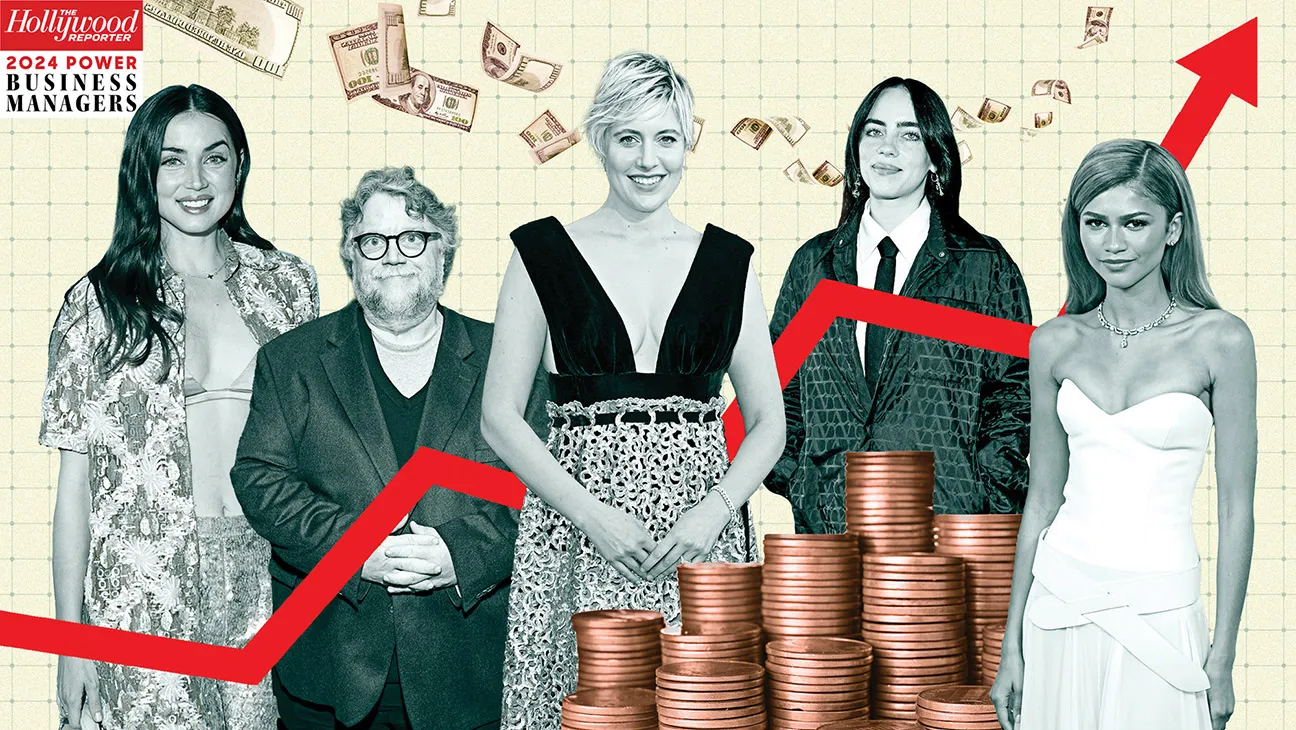È la prima volta che la Cineteca Nazionale comunica il proprio patrimonio all’esterno attraverso la rete. La terza giornata del festival Custodi di sogni ha aperto le porte dell’istituzione o, meglio, ha aperto… il link.
Il primo appuntamento della mattina è stato la Presentazione del Catalogo filmografico online della Cineteca Nazionale, con Marina Cipriani e Steve Della Casa. Il progetto di pubblicazione del catalogo è in via di esecuzione e si spera verrà ultimato entro giugno o luglio di quest’anno. Si tratta di un’opera molto importante: rendere nota tutta la collezione filmica.
Marina Cipriani ha raccontato la nascita e la storia dell’istituzione: “Che cos’è la Cineteca Nazionale? È un settore del Centro Sperimentale di Cinematografia, che dal 1935, dalla sua istituzione, decide di costruire al suo interno una cineteca. Gli allievi si formavano vedendo film italiani e stranieri di vari paesi, che a quel tempo era la cineteca del nostro paese. Un nucleo, un corpus filmico straordinariamente importante costituito esclusivamente da copie uniche. È andato perduto per sempre per uno degli atti scellerati di requisizione dell’esercito tedesco dei beni culturali.”
Il 1949 è un anno cruciale. La Cineteca Nazionale assume una sua identità rimanendo all’interno del Centro Sperimentale. La legge n. 958 istituisce la Cineteca come archivio di stato e istituisce il deposito legale di film in anticipo sui paesi occidentali. Inoltre, aderisce ad una struttura fondamentale che è la FIAF, che sovrintende a tutte le attività di conservazione, di tutela e di catalogazione e promozione per gli archivi cinematografici internazionali.
“Tutte le leggi successive a quella del ’49 ribadiscono e ampliano il ruolo della Cineteca quale istituto depositario. Il suo patrimonio è dichiarato di pubblico interesse”, ha affermato Cipriani.
Negli ultimi anni il deposito si è esteso, la rivoluzione digitale ha avuto inizio. “L’archivio analogico della pellicola ha dovuto aggiornarsi e affrontare temi completamente nuovi, nell’ambito della descrizione e della conservazione. Stiamo parlando di circa 60 000 titoli di film, lungometraggi, cortometraggi, mediometraggi, film di finzione, documentari, film d’artista e serialità”
“È un patrimonio che naturalmente richiede attività di preservazione. La digitalizzazione è uno dei processi più importanti sul quale la Cineteca ha investito, sia dal punto di vista tecnologico sia in termini di carattere organizzativo”
Fin dal 1949, la Cineteca ha un compito: comunicare al mondo attraverso il prestito culturale il proprio patrimonio per la crescita della collettività, non a fini di lucro ma a fini didattici.
“Proprio per questo è nata l’esigenza di un catalogo. Un catalogo composto da un inventario (atto amministrativo patrimoniale, con la conta degli elementi che costituiscono il patrimonio), e dalla catalogazione (atto di conoscenza scientifica della collezione). È un linguaggio, anche convenzionale, che deve comunicare all’esterno. Si lavora per costruire delle strutture dati, delle strutture informative. Rappresenta la nostra memoria istituzionale. Soltanto conoscendo e descrivendo il patrimonio riusciamo anche a conservarlo. È qualcosa che si muove e si aggiorna”, ha raccontato Cipriani, prima di concludere con una citazione tratta dalle Città invisibili di Calvino: “Scambi di parole, di desideri, di ricordi”.
Sergio Bruno e Marco Meconi hanno poi presentato le attività di restauro e la digitalizzazione della Cineteca. Sono stati mostrati quattro cortometraggi curiosi, di indubbia importanza storica. Villa d’Este, di Enrico Guazzoni: un film in costume del 1947 dove vediamo un bacio rubato a una giovanissima Gina Lollobrigida. Mattino in Piazza Navona, di Vittorio Sala, del 1952, un prezioso documentario a colori che inquadra la vita romana nel periodo prenatalizio. Pietro di Jakob Laub, del 1960, che vede Vittorio Storaro come operatore e un irriconoscibile Marco Bellocchio, ai tempi in cui era ancora convinto di voler fare l’attore.
Per finire, Frammenti di Sapienza, di Paolo Franchi, del 1995. Un ritratto intimo della scrittrice catanese che commenta in prima persona le sue aspirazioni, le sue esigenze e le sue mancanze; una giovane Piera degli Esposti la raggiunge sul finire, in un momento tenero e ludico.
L’appuntamento pomeridiano è stato invece un salto nel presente, se non nel futuro della settima arte. Dalla rivoluzione digitale della mattina si passa alla rivoluzione seriale.
Franco Bernini e Gloria Malatesta hanno moderato l’incontro Il CSC e le serie tv, con ospiti gli ex allievi e le ex allieve del Centro Sperimentale: la regista Francesca Mazzoleni; gli attori Nicolò Galasso e Matteo Paolillo; le sceneggiatrici Elisa Dondi e Michela Straniero; lo scenografo Giuliano Pannuti; e il direttore della fotografia Leonardo Kurtz. Hanno raccontato le loro esperienze con il mondo della serialità e le differenze lavorative e creative rispetto ai tempi richiesti dal più tradizionale lungometraggio.
Nell’incontro sono emersi i pro e i contro dei diversi processi. La questione più urgente è forse quella dello sguardo, che da singolo quale è deve abbracciare la molteplicità altrui, come avviene nel mondo della regia quando si presta alla serialità.
Mazzoleni ha consigliato ai giovani studenti presenti all’incontro di “trovare il loro sguardo prima di lanciarsi nel mondo delle serie che… è un bel Lunapark”, aggiungendo anche che l’aiuto degli sceneggiatori nell’ambito seriale è di fondamentale importanza.
Quando questo confronto manca è difficile tenere le fila di una narrazione così estesa. In Supersex un grande aiuto è stato quello della direttrice della fotografia, Daria D’Antonio. Michela Straniero ha ribadito l’importanza di avere un head writer, una figura apicale che si prende la responsabilità del gruppo di sceneggiatori e che non può essere sostituita dal delegato di produzione, come spesso avviene.
“Non era nella writer’s room e non è stato partecipe delle decisioni che sono state prese. Per questo il lavoro preliminare delle letture con il regista e gli attori, prima di andare sul set, è fondamentale”, ha ribadito Straniero.
Elisa Dondi ha commentato i ritmi serratissimi che richiedono le serie tv: “Non si tratta solo di velocità di scrittura ma anche di velocità di ritmo. Nella Legge di Lidia Poët la velocità è funzionale al tema. La protagonista è un personaggio che è avanti rispetto al suo tempo; quindi, il ritmo diventa funzionale alla scrittura. In ACAB, ho sofferto questa continua richiesta. Ciò che scrivevamo era molto violento e avevo bisogno di trovare dei punti del racconto dove questa violenza si sedimentasse”.
Diversa, invece, l’esperienza di Leonardo Kurtz sul set della quarta stagione dell’Amica Geniale, “Non ho sentito tutta questa fretta. Abbiamo girato con una sola macchina da presa. Ce n’era una seconda sul set a disposizione ma è stata usata raramente.” Mentre gli orizzonti del racconto si estendono con la serialità, il tempo corre e l’algoritmo richiede di rincorrere ciò che ha funzionato, “un meccanismo molto tossico”, come ha commentato Mazzoleni.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma