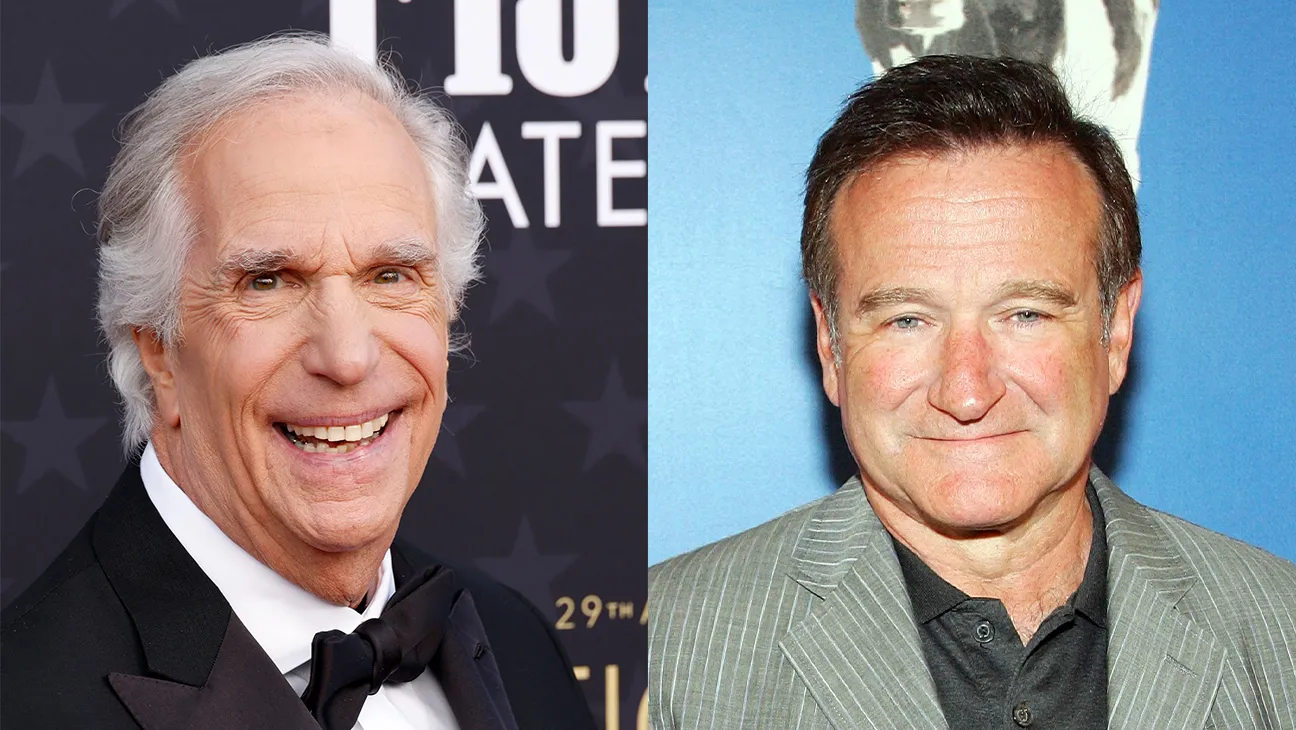A volte, il passato affiora da una manciata di cocci, da una scala consunta o da una parete d’intonaco corroso. E quando lo fa, spalanca finestre inattese sulla storia di uomini e donne che hanno lasciato tracce più fragili dei templi e dei fori imperiali, ma non per questo meno eloquenti.
La scoperta avvenuta a Ostia Antica, nell’estate del 2024, ha il sapore di queste rivelazioni inattese. Non parliamo di statue colossali o di basiliche sontuose, ma di un piccolo ambiente rettangolare, quasi nascosto agli occhi del visitatore, che si rivela invece uno scrigno prezioso di un’antica identità.
Si tratta di un mikveh, un bagno rituale ebraico, il primo conosciuto in tutto l’Occidente romano, fuori dai confini di quella Terra d’Israele che per secoli aveva custodito e tramandato questa pratica purificatoria.
Ma non si pensi a un ritrovamento casuale. Questo mikveh è emerso nel quadro di una campagna di scavo che porta un nome suggestivo quanto significativo: Ostia Post Scriptum.
Un titolo che sembra evocare la volontà di riprendere un discorso interrotto, di scrivere quelle pagine che ancora mancavano nella storia lunga e affascinante di Ostia, prima colonia romana, poi porto principale dell’Urbe e infine testimone silenziosa del crollo dell’Impero.
Il progetto, avviato nel 2022, nasce da un sodalizio scientifico fra il Parco Archeologico di Ostia Antica, diretto da Alessandro D’Alessio con la collaborazione di Claudia Tempesta, l’Università di Catania (Luigi Caliò) e il Politecnico di Bari (Antonello Fino). Una sinergia virtuosa che ha saputo unire lo sguardo analitico dello storico dell’arte con l’approccio ingegneristico del rilievo strutturale e la scrupolosità del metodo stratigrafico.
A sorprendere, in primo luogo, è il luogo del ritrovamento.

Scavi Ostia antica. Foto @Ministero della Cultura
L’area denominata “Area A” si trova nel cuore pulsante dell’antica Ostia, a pochi passi da edifici che chiunque abbia studiato archeologia romana conosce bene: i Grandi Horrea, il Piazzale delle Corporazioni, il Mitreo delle Sette Sfere. Eppure, in questa porzione di città – per lungo tempo lasciata ai margini dell’indagine archeologica – si celava un racconto rimasto muto per quasi duemila anni. E così, sotto la sabbia compatta e le radici delle piante, è riemerso un grande complesso edilizio.
Un edificio sontuoso, ci raccontano gli archeologi, con pavimenti a mosaico in tessere bianche e nere, ambienti articolati – ed è qui che la storia prende un’altra piega – cui è annesso un piccolo vano semi-ipogeo che subito ha destato l’interesse degli studiosi.
Immaginate una stanza rettangolare, chiusa a est da un’abside semicircolare. Un luogo che sembra pensato per il raccoglimento più che per l’ostentazione.
La soglia, in marmo, si apre su una scala di tre gradini consumati dall’uso, fiancheggiata da spallette in muratura rivestite d’intonaco idraulico.
Una scelta tecnica non casuale: l’intonaco serve a rendere impermeabile la struttura, necessità imprescindibile per un ambiente destinato a contenere acqua. E qui l’acqua non è un elemento ornamentale o funzionale: è sostanza e finalità.
Scendendo quei gradini, si raggiunge un pavimento in mattoni bipedali, collocato a un metro sotto il livello d’ingresso, e proprio accanto si apre un pozzo di captazione della falda, realizzato in cementizio e rifinito con una ghiera in mattoni. Un dettaglio tecnico che rivela molto: l’acqua non veniva raccolta e trasportata dall’esterno, ma sgorgava direttamente dal sottosuolo.
È questa l’acqua “viva” prescritta dalle norme rabbiniche per la purificazione rituale, quell’acqua che, secondo la Mishnah e la Tosefta, doveva essere naturale, non toccata da mano umana, per assolvere alla funzione di taharah, la purezza.
E non è tutto. Un foro passante nella muratura suggerisce l’esistenza di un sistema per l’adduzione di acqua supplementare, forse piovana, come previsto dalle regole halakhiche.
L’insieme degli indizi punta a una lettura inequivocabile: siamo davanti a un mikveh, un bagno rituale per la purificazione di persone o oggetti, secondo i precetti del giudaismo antico.

Scavi Ostia antica. Foto @Ministero della Cultura
La scoperta non si ferma all’architettura. Gli archeologi, scavando tra i livelli di abbandono e di obliterazione, hanno riportato alla luce lucerne con la menorah, il celebre candelabro a sette bracci, simbolo per eccellenza della fede ebraica, accanto a un lulav, il ramo di palma utilizzato nella festa di Sukkot. Oggetti che non lasciano spazio a interpretazioni alternative. A Ostia, nel V o VI secolo d.C., esisteva una comunità ebraica coesa, che praticava i propri riti in un edificio dedicato e che manteneva vive le proprie tradizioni pur in un contesto urbano dominato da altre fedi e culture.
Vale la pena riflettere un momento su cosa significhi, sul piano storico, questo ritrovamento. I mikva’ot sono ben noti nell’area della Palestina romana e bizantina, dove, già in età asmonea, tra II e I secolo a.C., se ne documentano numerosi esempi. A Gerusalemme, a Qumran, a Sepphoris, queste vasche rettangolari coperte, scavate nel terreno e rivestite di intonaco, segnano la vita quotidiana delle comunità osservanti. Ma fuori da quella regione, fino ad oggi, la diaspora occidentale non aveva mai restituito strutture simili di epoca romana o tardo-antica. Fino a Ostia.
La sinagoga di Ostia, scoperta nel 1961 lungo la via Severiana, aveva rappresentato una prima rivelazione, la prova tangibile della presenza di una comunità attiva, organizzata e radicata. Ora, il mikveh aggiunge un tassello essenziale: la prova che quella comunità non solo esisteva, ma viveva intensamente la propria fede, mantenendo pratiche antiche pur lontana dalla patria d’origine.
Per gli archeologi che hanno condotto le indagini – fra cui Davide I. Pellandra, Mario Mazzoli e Marco Vitelli dell’Associazione Archeologia Subacquea Speleologia Organizzazione (A.S.S.O.) – la sfida è stata duplice: da un lato, la necessità di una metodologia rigorosa, capace di documentare ogni fase stratigrafica e ogni traccia, anche la più minuta; dall’altro, la consapevolezza che ogni reperto andava contestualizzato in un quadro storico più ampio, evitando letture affrettate o suggestioni fuorvianti.
Il mikveh si inserisce in una sequenza d’uso che dal I secolo d.C. si protrae fino al VI, secolo in cui le lucerne con menorah confermano la continuità di una presenza ebraica viva e attiva.
E non si può ignorare il valore simbolico di questa scoperta. Ostia, porto di Roma, crocevia di merci e uomini, di lingue e di culti, si conferma una città cosmopolita anche nella sua stratificazione religiosa. In questo microcosmo urbano, la comunità ebraica trovò non solo spazio per i propri commerci e le proprie attività economiche, ma anche luoghi di culto e di aggregazione, dove poter celebrare riti e osservanze, mantenendo saldo quel legame spirituale con Gerusalemme che nessuna distanza geografica poté mai recidere.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma