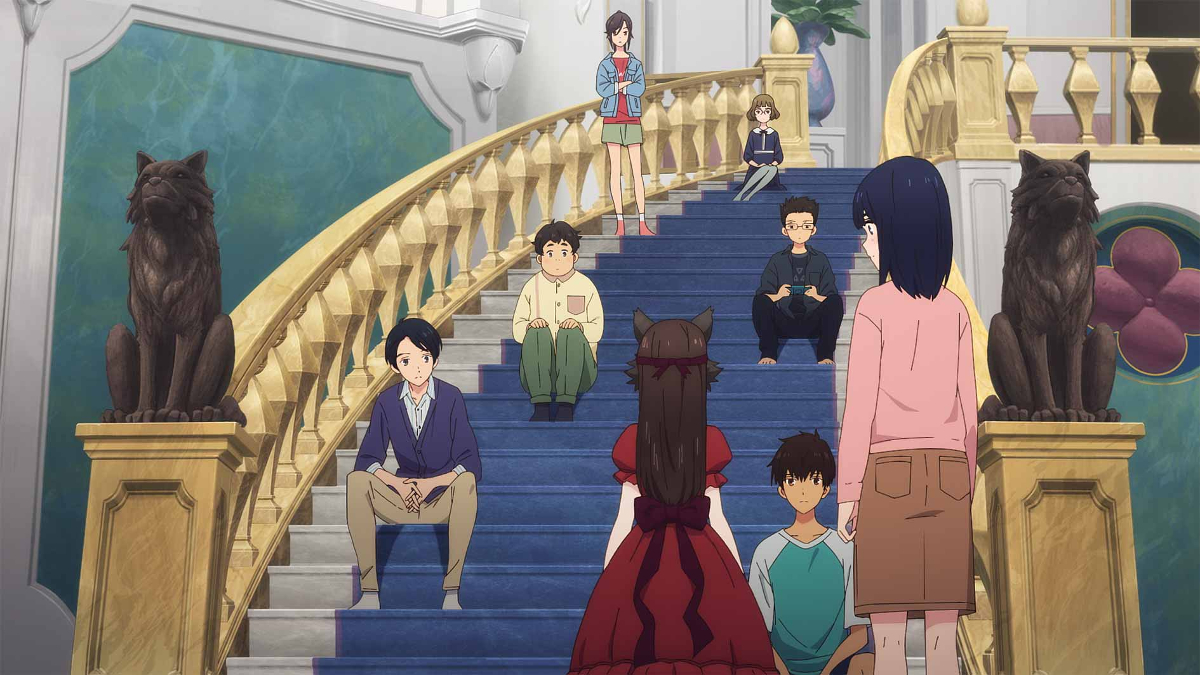L’epica del fallimento è una contro-epica che può essere raccontata solo con i toni dell’elegia. Un filtro malinconico che rende seppiato anche il fotogramma che racconta il presente, filtra la visione e la distanzia – i personaggi in campo, così, guardano da lontano la vita che stanno vivendo. Mentre la stanno vivendo. In un cinema internazionale dominato da eterni Avengers, chi si incarica di raccontare non il superpotere ma il suo rovescio credo sia tutto sommato benemerito. Dico meglio: il superpotere “scaduto”, o l’illusione del superpotere.
Tra i film dei fratelli Coen che ho amato di più metto senza dubbio il meno celebrato A proposito di Davis (2013, titolo originale più efficace: Inside Llewyn Davis), con quella luce grigia che permeava ogni scena, con un protagonista goffo e assorto, teso a raggiungere qualche risultato dignitoso nella musica. Ci prova, ma riesce poco, riesce sempre a metà. Fino a che non si trova ad ascoltare, in un locale, un tizio giovane e riccioluto che ha proprio l’aria di essere Bob Dylan. Di fronte alla sproporzione di certi talenti, tutti siamo “soccombenti”, per usare la chiave – è un participio presente, non a caso; il loop del fallire in tempo reale – usata da Thomas Bernhard nel suo romanzo su Glenn Gould.
Non è un romanzo su Glenn Gould
Ma devo correggere anche qui: non è un romanzo su Glenn Gould, ma sulla manifestazione del suo genio in una comunità di musicisti abnegati e dotatissimi. Di fronte al genio che fai? Soccombi. Per quanto infine possa soccombere lui stesso, schiacciato dalla propria stessa straordinarietà. Fatto è che raccontare vite non eroiche, esistenze in cui la riuscita e il successo sono e restano una chimera, è balsamico: tanto più in questa interminabile stagione di talent. Ma sì, sì, canta, danza, recita pure tu! Non ci perdi niente! Avrai ben più dei quindici minuti di celebrità previsti avaramente e proverbialmente da Andy Warhol per ciascun abitante di questo pianeta. La prova vera è la durata: “Pensa a quanto sei durato!” dice, in uno degli ultimi romanzi di Philip Roth, un amico a un vecchio attore che sente di avere perso la sua magia.
Malinconia ai livelli di guardia
Guardando La quattordicesima domenica del tempo ordinario, il nuovo film di Pupi Avati, ho pensato che fosse un’opera-nodo in cui si intrecciano i fili di molti altri suoi film. Non è un’osservazione originale, ma se penso a uno dei suoi lavori che amo di più, fin dal titolo, Ma quando arrivano le ragazze (2005), mi dico che il tema dell’Avati “elegiaco” è l’effettiva sproporzione fra le ambizioni che coltiviamo e l’effettivo compimento, lo squilibrio doloroso tra ciò che vorremmo essere e ciò che riusciamo a essere. Il che, per essere chiari, non riguarda solo i “falliti”, ma anche quelli baciati dalla fortuna: “Facciamo quello che possiamo, diamo quello che abbiamo!” esclama un personaggio di Henry James che fa lo scrittore e sbatte la testa sulla impossibilità di avere una seconda occasione. Per fare meglio, per fallire meno. “Può essercene soltanto una” conclude.
Nel film del 2005 Avati raccontava le vite parallele di due aspiranti musicisti – uno destinato a mollare la presa, l’altro avviato verso gli applausi (e che somiglia al suo amico Lucio Dalla). Nel nuovo film, c’è una scena in cui Marzio Barreca (Gabriele Lavia), cantautore irrisolto, sfinito dai fumi dell’alcol e dai suoi lampi di follia, si ritrova ormai vecchio a cantare per una televisione locale di Bologna. La malinconia è ai livelli di guardia: a Barreca, appena finisce di cantare il suo pezzo, tocca fare uno spot per un ristorante.
Mi ha fatto ricordare lo struggimento del Ginger e Fred di Fellini, il baraccone televisivo e la finta gloria – ah, i film cosiddetti senili! Svalutati da critici pigri e inariditi, sono invece capaci di uno sguardo radicale, spietato e pietoso insieme. Così La quattordicesima domenica di Avati: dove l’autore riesce a tirare fuori qualcosa di profondo, forse di ineffabile, che lo riguarda.
Fra passato e presente
Una gelateria della vecchia Bologna è il punto di partenza per quella che Antonio Tabucchi avrebbe chiamato “autobiografia altrui”: la voce narrante, in molti momenti, sembra proprio quella del regista, che attinge alle sue memorie private, richiama i confini del suo mondo di infanzia e adolescenza, via Saragozza, il gelataio che esaudiva i sogni, il senso di vergogna che provò ragazzino di fronte a un padre bello e pieno di charme morto troppo presto, l’idea di poterlo rincontrare per raccontargli finalmente com’è andata la sua vita, pur sapendo di non essere all’altezza del suo giudizio. E nemmeno dei propri stessi sogni.
Il movimento fra passato e presente – Barreca giovane (Lodo Guenzi, notevolissimo!) e Barreca vecchio (Lavia perfettamente in parte) – accentua questa verità indigesta: non diventiamo quello che vorremmo essere, ma quello che riusciamo a essere. E forse, dispersa la magia del chiosco dei gelati, anche nel cosiddetto privato siamo più sfasciati e difettosi di quanto ci illudiamo. Barreca non è all’altezza della storia d’amore divorante con “la ragazza più bella di Bologna”: riesce a rovinarla, a intossicarla, a distruggerla. L’amico con cui formava il duo “I Leggenda” si è salvato? Be’, ha raggiunto una posizione, si è messo al sicuro, e poi? Eravamo quattro amici al bar, come nella vecchia canzone di Paoli, «destinati a qualche cosa in più / che a una donna ed un impiego in banca» (da prendere alla lettera, nel film di Avati. Forse, ora che ci penso, agisce anche, da qualche parte, Il cielo in una stanza).
Ognuno a rincorrere i suoi guai
E poi? Ognuno a rincorrere i suoi guai: con il fiato della morte sul collo. I critici invecchiati male, quelli che bofonchiano e scatarrano alle anteprime per la stampa, forse faranno finta di non sentirlo, ma c’è, soffia anche sul loro collo: e li costringerebbe a guardarsi come in certi momenti si guarda Barreca. Con disperazione calma. O come lo guarda Sandra, la ragazza ormai donna attempata (interpretata in modo sorprendente e con grazia da Edwige Fenech): severa e compassionevole a un tempo, come chi è capace – infine – di perdonare tutto.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma