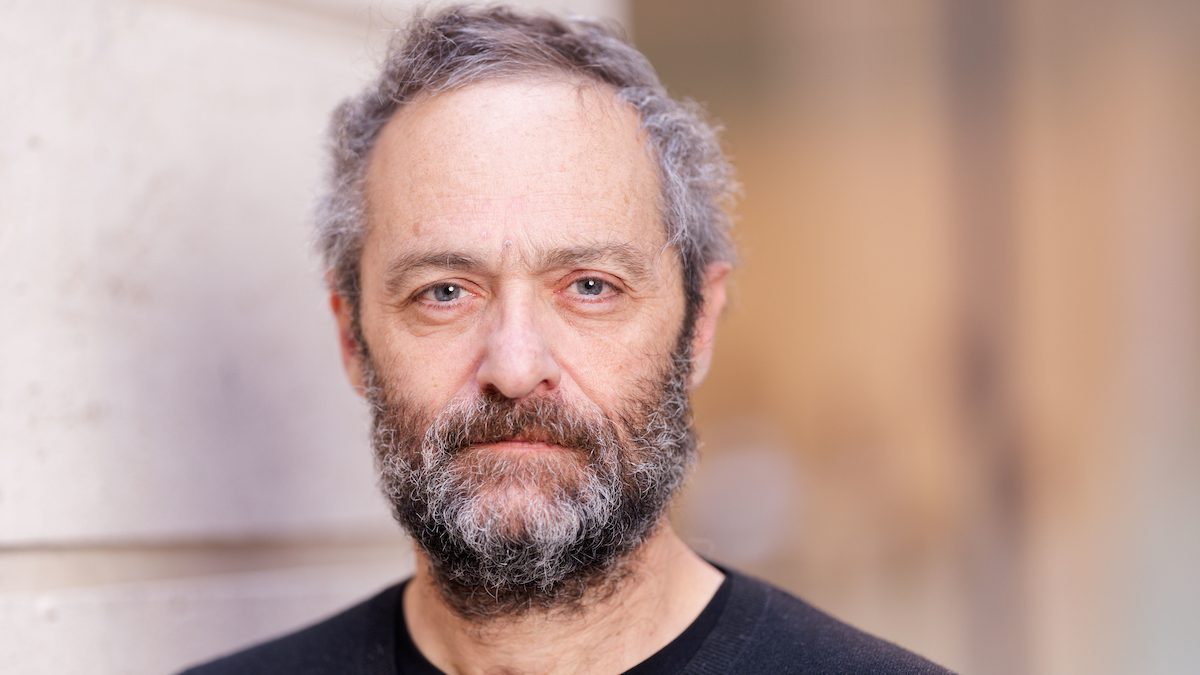Per lavorare a La zona di interesse, lo straziante dramma di Jonathan Glazer a tema Olocausto, il direttore della fotografia polacco Łukasz Żal ha dovuto dimenticare tutto ciò che gli era stato insegnato sul creare belle immagini.
Il film di Glazer, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Martin Amis del 2014, segue le attività apparentemente banali del comandante di Auschwitz Rudolf Höss (Christian Friedl) e di sua moglie Hedwig (Sandra Hüller), mentre cercano di costruire una vita da sogno per la loro famiglia nella casa con giardino di fianco al campo. La straordinaria estetica uniforme e monocromatica che Żal aveva perfezionato nel suo lavoro su Ida e Cold War di Pawel Pawlikowski, per cui era stato candidato all’Oscar, non andava bene per la storia di Glazer, che mirava a evocare la banalità del male rifiutandosi di mostrare Höss e Hedwig se non per quello che erano: persone ordinarie, quasi noiose, che commettevano crimini indicibili.
Cosa le ha fatto venire voglia di essere coinvolto nel progetto?
Ricordo di aver letto la sceneggiatura e di essere rimasto davvero colpito. Non avevo mai visto questo tipo di approccio in un film sull’Olocausto. Non era l’approccio hollywoodiano, che spesso riesce solo a feticizzare la storia, persino nel modo in cui vengono mostrati i personaggi, nell’aspetto delle uniformi, nell’uso del colore e delle ombre. Qui, Jonathan Glazer voleva che tutto fosse chiaro e luminoso, che tutto avesse un aspetto grazioso, luminoso e normale. Ricordo di aver letto tutto questo e di aver pensato: voglio farlo. Voglio girare questo film perché non ho mai visto niente del genere prima d’ora e perché va al cuore di qualcosa che personalmente mi interessa molto, cioè il perché le persone scelgono il male, come fanno trattare l’omicidio come qualcosa di ordinario, come rammendare una giacca o pulire i pavimenti.
Come avete proceduto, lei e Glazer, per tradurre quest’idea – la banalità del male – in un linguaggio visivo?
Mi sono reso conto che per questo film dovevo dimenticare tutto ciò che mi era stato insegnato riguardo all’illuminazione, alla manipolazione di un’immagine, l’intero processo in cui cerco di catturare dei momenti, di interpretare la realtà con la mia macchina da presa. Questo sarebbe stato l’esatto contrario. Andava contro il tipico cinema hollywoodiano, quello stile in cui si cerca di raccontare la storia con delle belle luci e dei primi piani che ti fanno entrare nelle emozioni di una scena, dei personaggi. Il nostro approccio era completamente diverso: creare immagini brutte, repellenti, quasi obiettive.
L’aspetto più importante era non feticizzare l’immagine, non giudicare, non prendere le decisioni che prenderebbe di solito un direttore della fotografia. Glazer e io ci siamo detti all’inizio che la macchina da presa in questo film doveva essere come un grande occhio che vede tutto. Ovviamente, abbiamo fatto alcune scelte estetiche, ma ho cercato di limitare il mio impatto su questo film il più possibile, di dimenticare il mio approccio all’estetica, alla composizione, e di impostare l’inquadratura nel modo più semplice possibile.
Che cosa ha significato nella pratica?
Significava adottare un approccio diverso, usare la luce naturale, anche una “brutta” luce. A scuola, mi era stato insegnato a fare le riprese con una buona luce da dietro oppure all’alba o al tramonto, quando la luce è più bella. Qui giravamo a mezzogiorno, alle 13, alle 14, alle 15, quando la luce è più forte. Per me era davvero entusiasmante, perché andava proprio contro l’idea di creare delle belle immagini. Invece, quello che per me era bello era il loro aspetto onesto e autentico.
Ho dovuto dimenticare quello che sapevo sull’estetica, sull’usare la sezione aurea per le inquadrature, tutti quei trucchetti che impari e poi usi continuamente: un po’ di luce da dietro qui, un po’ di camera flare (riflessi di luce, ndr) là, un po’ di profondità di campo, tutti i modi in cui puoi usare la macchina da presa per la manipolazione emotiva. Volevamo un approccio diverso, mostrare questi personaggi in un modo che fosse obiettivo, cercare di sparire il più possibile e mostrare semplicemente le cose com’erano.
Ricordo che in una delle prime riunioni sul set stavamo discutendo di una scena, che alla fine non è entrata nel montaggio finale del film, in cui un personaggio guarda fuori dalla finestra, e nella scena successiva sentiamo uno sparo e sappiamo che è stato ucciso. Stavo impostando l’inquadratura e ho suggerito di fare un bel primo piano del tizio che guarda fuori dalla finestra. E Glazer ha detto: “Non credi che questo sarebbe davvero emotivo e manipolatorio? E se lo riprendessimo da lontano, e mostrassimo semplicemente questo tizio in piedi davanti alla finestra, senza far vedere nemmeno il suo volto?”. È lì che è scattato qualcosa in me. Ho capito come avremmo fatto il film.
Questo è molto evidente nelle scene in casa, che sono state riprese con dieci telecamere fisse, come in un reality show.
C’era quest’idea: “Il Grande Fratello in una casa nazista”. Era un procedimento diverso da quello a cui sono abituato, perché tutto il mio lavoro si è concentrato sulla preparazione, sul decidere dove mettere le telecamere. Impostavamo le cose nella casa e poi scendevamo nel seminterrato con il mio operatore e la mia squadra, e analizzavamo le immagini insieme a Jon. Era un continuo cambiare gli obiettivi, le posizioni. C’era un procedimento simile ogni giorno, con ogni scena.
Una buona parte dei miei compiti consisteva nel preparare il flusso di lavoro e coordinare la tecnologia. Abbiamo collegato tutte le telecamere con un cavo di fibra ottica, perché non volevamo rischiare interruzioni nella frequenza con una connessione remota. Quindi avevamo queste dieci telecamere con i cavi, sparse per la casa. Ogni stanza aveva un buco per i cavi, era come un formaggio svizzero. Eravamo tutti collegati con questo sistema di comunicazione avanzato, in modo che io potessi parlare con tutto il team, coordinare tutte queste telecamere e fare i cambiamenti necessari. Ogni giorno dedicavamo qualcosa come cinque o sei ore per la preparazione delle riprese del giorno successivo.
Ma quando iniziavano le riprese, ci sedevamo semplicemente a guardare. Gli attori facevano la scena, ripresa dopo ripresa, e poi si faceva tutto in una sessione unica: tutte le inquadrature, i primi piani, i piani medi, mentre la luce cambiava, le nuvole passavano, il sole sorgeva o tramontava. Stavamo semplicemente osservando con le nostre telecamere.
Che attrezzatura ha usato?
Abbiamo fatto le riprese con delle telecamere Venice della Sony perché hanno un sistema di estensione Rialto in cui puoi collegare il corpo della telecamera con dei cavi di fibra ottica a dei piccoli sensori 14 x 10 cm, che si possono facilmente attaccare a un muro della casa o nascondere in un armadietto. La ripresa in sé veniva fatta senza la troupe sul set con gli attori. Eravamo tutti nel seminterrato, a guardare i monitor.
Volevamo che gli obiettivi fossero piccolissimi e moderni. Abbiamo scelto quelli Leica, con l’idea di usare attrezzature contemporanee per conferire un aspetto da XXI secolo, non vintage. Abbiamo girato in digitale e volevamo che sembrasse digitale, non pellicola, non seppia. E abbiamo usato dei rapporti focali molto alti per avere tutto a fuoco nell’inquadratura, in modo da non dover decidere per lo spettatore cosa guardare. Rientrava tutto nell’idea di manipolare il meno possibile.
Questo modo di girare ha cambiato la sua visione di altri film storici realizzati in modo più tradizionale, in particolare su questo argomento?
L’approccio dovrebbe dipendere dalla storia che si vuole raccontare. Però sì, ora mi disturba guardare una versione molto hollywoodiana di questo tipo di storia, vedere attori bellissimi, sotto luci bellissime, con uniformi bellissime. Perché sento che non è autentico, che non era così. Non era bello e drammatico o emotivo in quel modo. In quel tipo di omicidi, non c’era una grande filosofia dietro. Uccidere era come parcheggiare l’auto, come chiudere una porta. Questa è la cosa terribile e dolorosa, e il motivo per cui dobbiamo parlarne proprio ora, in questo momento. Perché se si guarda il mondo adesso, si capisce che non siamo cambiati. Non importa che si tratti di russi, ucraini, israeliani, palestinesi o polacchi. Siamo tutti umani, siamo tutti uguali. A volte possiamo essere straordinari e coraggiosi. A volte siamo orribili e mostruosi. Ma dobbiamo guardarci per come siamo, e non distogliere lo sguardo.
Traduzione di Nadia Cazzaniga
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma