
Dottore in filosofia e teoria dell’architettura, Paul B. Preciado è uno dei massimi esponenti della filosofia contemporanea. I suoi lavori spaziano dai gender studies, alla pornografia, alla sessualità, passando la performance e l’arte contemporanea. Ha insegnato Storia politica del corpo all’università di Parigi VIII e ha diretto l’Independent Studies Program del MACBA di Barcellona. Ha inoltre curato il padiglione di Taiwan della Biennale di Venezia del 2019. Attualmente è filosofo associato presso il Centre Georges Pompidou a Parigi. Ecco la sua intervista in esclusiva con The Hollywood Reporter Roma, nella quale ci parla del suo primo lungometraggio, Orlando.
Il tuo Orlando è un’autobiografia di tutti, come l’Orlando di Virginia Woolf è la tua biografia politica vera e propria – così dichiari nella prima scena del film. Qual è la differenza, se c’è, tra sé e gli altri quando ci troviamo insieme sulla soglia di un nuovo mondo “farmaco-liberato”?
Beh, sono nato in Spagna negli anni ’70, in una società fascista, in un mondo in cui la transizione di genere era, se non del tutto vietata, almeno considerata un’esperienza marginale, patologica e potenzialmente letale. Mi sentivo una persona non binaria fin da piccolo, ma ero circondato da una società iper-binaria. Il mio desiderio di fare un adattamento dell’Orlando è nato proprio dall’inquietante sensazione che Virginia Woolf avesse scritto la mia biografia 50 anni prima della mia nascita. O almeno questa è stata la mia impressione quando ho letto il libro per la prima volta, da adolescente. Ben prima di aver conosciuto qualcuno che avesse subito una transizione di genere, sentivo che la mia vita futura sarebbe stata possibile grazie all’esistenza di quel libro. Quindi, in un certo senso, il libro è diventato il mio talismano di genere.
Poi, quando ho iniziato a rileggere i lavori di Virginia Woolf per preparare la sceneggiatura, ho capito che la sua opera poteva essere capita molto meglio se pensavamo alla Woolf come a un’autrice non binaria. In questo senso, sia Virginia Woolf che Orlando sono oggi più che mai in linea con i nostri tempi. Credo che questa sia stata la mia intuizione principale: leggere Virginia Woolf come un’autrice non binaria e fare un film non binario. Oggi gli Orlando entrano in un mondo in cui l’esperienza della transizione è possibile, in cui esiste già un linguaggio e alcune tecniche sociali e politiche che permettono questa transizione. Questo non significa che oggi la transizione sia “facile”: c’è ancora un’eccessiva medicalizzazione dell’esperienza di transizione. Nel film interpreto la poetica di Orlando contro la riduzione medica, psicologica e legale dell’esperienza non binaria del mondo.
Come hai conosciuto i tuoi Orlando?
Per me era chiaro che non sarei stato il personaggio principale del film. La mia voce avrebbe attraversato il film, ma il corpo sarebbe stato multiplo. Quello che mi interessava era creare una genealogia politica che dimostrasse che l’Orlando di Virginia Woolf non era una figura fantascientifica, qualcosa di simile alla creatura di Frankenstein, ma che si trattava di qualcosa di reale e che effettivamente cambiava nel tempo. Ho fatto un casting per cercare l’Orlando di oggi, tra i 4 anni e gli 80 anni. Si sono presentate 100 persone.
Poi ho avuto questa visione del film: ogni personaggio avrebbe incarnato uno dei momenti della vita di Orlando. Per me era altrettanto importante che ci fossero degli Orlando adolescenti che assumono bloccanti ormonali, come Ruben, che aveva 13 anni quando abbiamo iniziato a lavorare al film, o degli Orlando settantenni, come la storica donna trans Jenny Bel’Air, senza la cui presenza sarebbe stato impossibile anche solo concepire la mia transizione.
L’esperienza del tuo occhio nella macchina da presa e quella della tua mano con una penna o una tastiera. C’è una differenza nel tuo corpo quando fai un film e quando scrivi? Lo so, questo è il tuo primo film, ma sei dotato di una grande immaginazione…
Tendiamo a immaginare la scrittura come qualcosa di solitario e individuale, e il cinema come qualcosa di collettivo. Ma la verità è che la scrittura è già collettiva: quando scrivo sono un lettore già in dialogo con altri testi. Quindi, la scena della scrittura è già un congresso, un circo popolato di parole e voci piuttosto che una singola mano con una penna. Inoltre, mi sento un corpo scrivente: ci si chiede sempre quali corpi e per quali ragioni siano stati storicamente in grado di scrivere o a cui sia stato negato il privilegio della scrittura. Per esempio, fino all’inizio del XX secolo pochissimi corpi a cui è stato assegnato il genere femminile erano in grado di scrivere. Allo stesso modo, fino all’avvio del processo di decolonizzazione politica erano pochi i corpi che erano stati razzializzati come non bianchi dalle tassonomie razziali a poter scrivere. Per non parlare dei corpi contrassegnati come trans, disabili o malati di mente. La scrittura e la cinematografia sono entrambe tecnologie di produzione di soggetti e, in questo senso, strumenti di potere.
Ma la differenza principale tra scrivere e fare film è l’economia dei film, non parlo solo di denaro, ma della rete di industrie e istituzioni che rendono possibili i film. Nel mio caso, ad esempio, ho potuto realizzare questo film grazie ad ARTE Francia/Germania, una televisione sostenuta dallo Stato che non rischia di essere spazzata via dalla privatizzazione neoliberista. Quando si scrive, l’unico limite è la propria immaginazione, le sue frontiere cognitive, per così dire, mentre quando si fa un film, tutto deve essere tradotto in cifre e calato in un contesto materiale. In questo senso, fare cinema è come fare politica: le idee si misurano costantemente con la realtà, devono trovare una forma materiale, un corpo concreto che dia loro voce e una situazione pratica in cui esprimersi. A causa di questa costante relazione tra concetti e corpi, mi piace pensare sia alla scrittura che alla cinematografia come a pratiche filosofiche.
Pensi che Virginia Woolf avrebbe fatto un film per scrivere una lettera d’amore a tutti e quasi tutti (Orlando è, forse, la lettera d’amore più lunga e divertente e avventurosa del mondo occidentale) e per raccontarci la storia dei corpi in transizione?
Virginia Woolf vide l’emergere del cinema come mezzo di comunicazione popolare negli anni Venti e, come molti suoi contemporanei, ne aveva paura. Lo stesso anno in cui scrisse l’Orlando, nel 1927-28, scrisse un breve testo divertente intitolato “Cinema”, in cui parla del cinema come di un crogiolo in cui si può gettare tutto ciò che si trova nella vita reale, parole, suoni, immagini, colori… e cercare di cucinare qualcosa che ecceda la realtà stessa. Temeva che il cinema potesse dislocare o sostituire la complessità dell’esperienza reale, un po’ come oggi vediamo la Realtà Virtuale o l’IA. Ma nonostante le cautele della Woolf nei confronti del cinema, vedo la sua scrittura non binaria come altamente cinematografica, una sorta di cinepresa decentrata che è in grado di “sentire” in un modo non binario molto più che umano.
Hai tenuto conto delle tue esperienze con Orlando, e delle reazioni ad esso, per Dysphoria Mundi, il tuo ultimo libro in uscita (in Italia è pubblicato da Fandango)?
Ho girato il film mentre scrivevo il libro. E in qualche modo il film è una parodia filosofica del mondo che verrà, il lato B cinematografico del libro. Volevo abbozzare una comprensione utopica e poetica di ciò che significa transizione di genere in una società ancora fortemente binaria e patriarcale, che non ha nulla a che fare con l’essere disforici di genere o affetti da una patologia. Ma piuttosto uscire dall’epistemologia della modernità, dove l’identità sessuale e di genere sono fisse, e passare a una comprensione della soggettività come già relazionale e mutevole nel tempo.
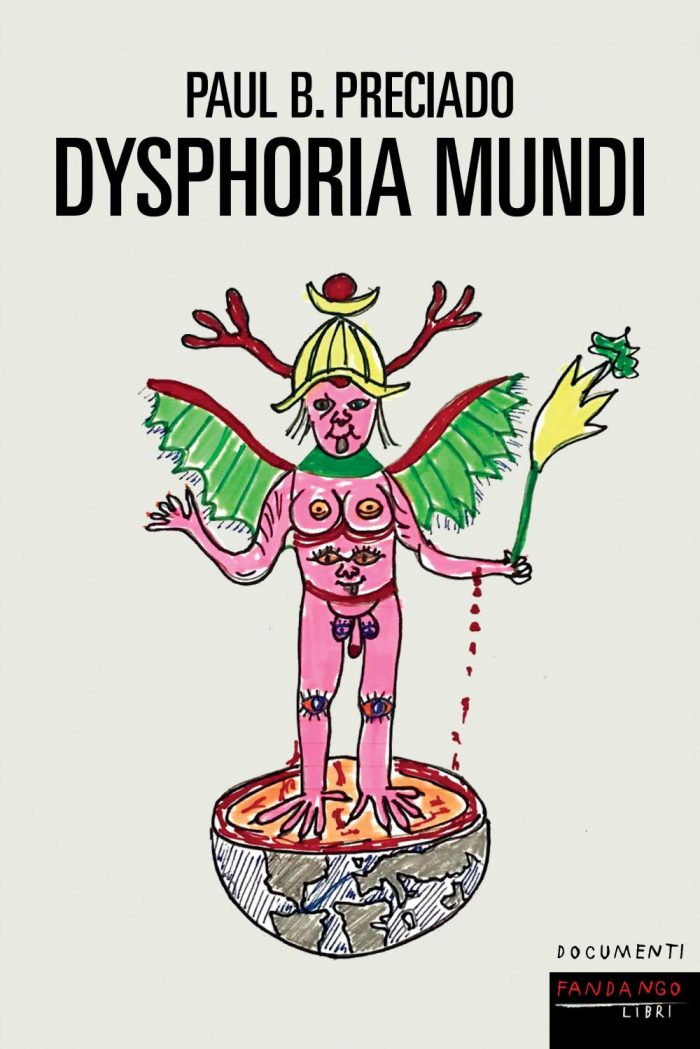
La copertina di Dysphoria Mundi, di Paul B. Preciado, edito da Fandango
Le questioni di genere e di transizione hanno turbato molte persone (sicuramente qui in Italia). Credi che sia solo perché non lo capiscono o perché li spaventa?
Viviamo ancora in un regime politico sessuato e binario in cui tutto ciò che non è binario è considerato patologico o una minaccia sociale. Ma le cose stanno cambiando. Sono sicuro (o almeno spero) che in meno di 50 anni passeremo collettivamente a un regime non binario e la definizione del proprio genere o della propria sessualità come maschile e femminile o eterosessuale e omosessuale sarà obsoleta e passata di moda come quando oggi sentiamo parlare di donne isteriche nel XIX secolo.
La transizione è una questione di vita umana. Tutti noi siamo corpi in transizione. Come scrivi in Dysphoria Mundi, come possiamo vedere in Orlando, il pianeta Terra, il tempo e i tempi sono in transizione. La migrazione porta con sé delle storie, forse si potrebbe sostenere che senza migrazione fisica – in tutti i sensi di questo aggettivo – non c’è storia.
Hai ragione. Vedo la storia di Orlando come una storia di migrazione in un senso marcato del mondo. Migrazione di parole, di lingue, di corpi, trasposizione di genere e anche di confini nazionali e sessuali. Migrazione epistemica… potremmo dire: passaggio da un regime politico gerarchico a un nuovo regime copyleft non gerarchico.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma









