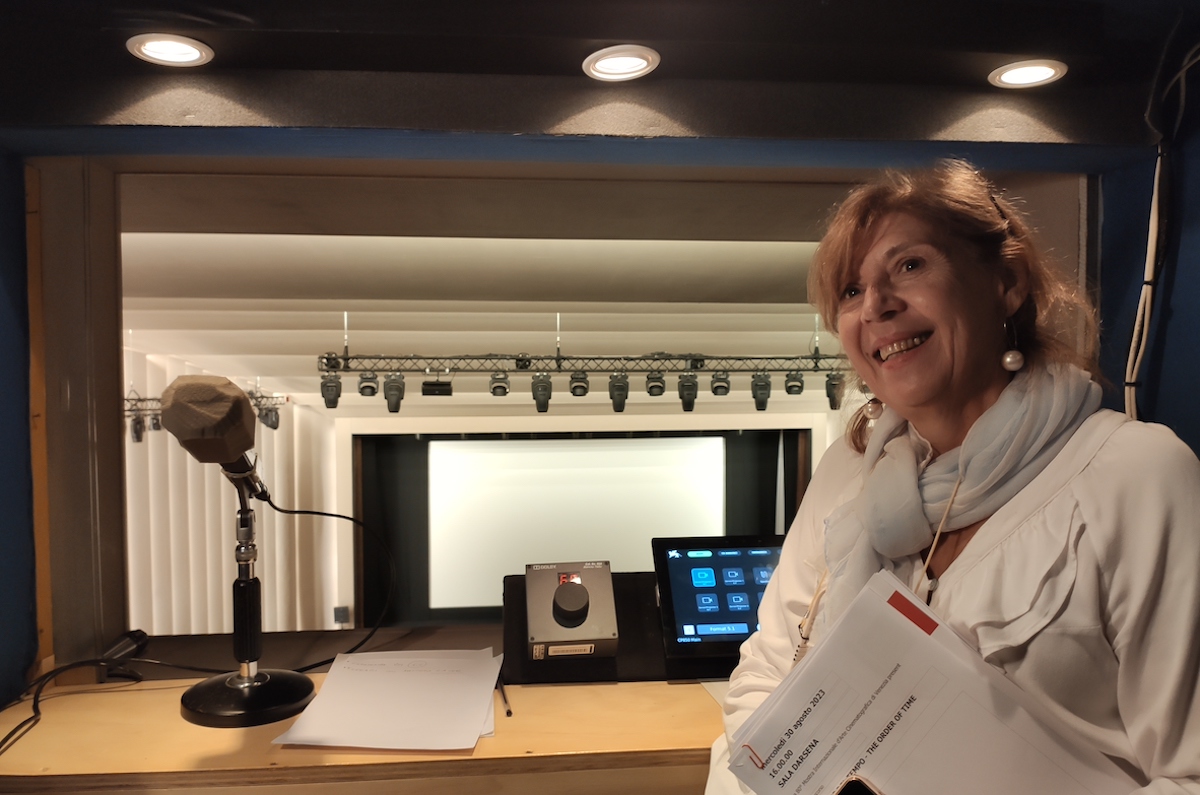Difficile commentare un palmarès di questo tipo, i premi di Venezia 80 escludono molti ottimi film – su tutti Bastarden di Nikolaj Arcel, La bête di Bertrand Bonello, che ha sì diviso, ma meritava attenzione per alcune oggettive eccellenze, Enea di Pietro Castellitto, pare in corsa fino all’ultimo – e fanno un disastro in sede di premiazione degli interpreti (senza neanche la “solita” scusa di trovare uno strapuntino per gli italiani) e per il resto distribuisce riconoscimenti più politici che per meriti artistici.
Potevamo aspettarcelo: nel consesso dei giurati c’erano troppi registi, troppi ego, troppe visioni diverse ed era pure troppo giovane il presidente che, per quanto talento abbia, è un ragazzo rispettoso che si è trovato davanti almeno un paio di lupi (stessa sorte che, sostenendo Castellitto, deve essere toccata Mainetti, provando a immaginare come sia andata).
Una cosa, però, sembra evidente: la leggenda metropolitana che da De Sica a Fellini, da Welles a Kubrick vogliono i grandi cineasti mal sopportare gli attori, un po’ deve essere vera. Fermo restando che quelli citati hanno fatto la fortuna di ogni loro singolo interprete, chi si è trovato a dar premi in questo Venezia 80 ha azzeccato il Leone d’Oro – ma era impossibile sbagliarlo, Lanthimos ha staccato tutti gli altri di almeno tre lunghezze – con Poor Things, per poi sfogarsi con le altre categorie e fare un disastro totale con le coppe Volpi.
Premiare la Priscilla Presley di Sofia Coppola, Cailee Spaeny, per uno dei film più insulsi della storia del festival (ma d’altronde la ragazza è dai tempi di uno dei Leoni d’oro meno meritati di queste 80 edizioni, Something, che ha poco da dire e lo fa male) è un insulto a Emma Stone, Lèa Seydoux, Amanda Collin, Jessica Chastain, Carey Mulligan. Una prova sciatta, ordinaria che meritava un Razzie Award, o il Premio Corinna dell’anno, in onore della cagna maledetta di Boris. Peggio si poteva fare solo premiando Penelope Cruz.
Le coppe Volpi
È andata meglio tra i maschi, il riconoscimento a Peter Sarsgaard non è scandaloso – il film è bello e lui sa dipingere un malinconico demente con grazia – ma rimangono fuori mattatori che hanno fatto spellare le mani: Caleb Landry Jones su tutti (come si fa a non premiarlo in tutte e due le categorie? Meritava la Volpi femminile pure per la sua Edith Piaf), Mads Mikkelsen, Willem Defoe e Mark Ruffalo (ma Lanthimos premiato probabilmente li ha messi fuori gioco, come successo per la Stone), Pierfrancesco Favino (ma in Adagio c’era l’imbarazzo della scelta), Bradley Cooper che in Maestro si è superato, Guillaume Canet nel film di Brizé Hors-Saison, facendo una veloce carrellata.
Come se avessero voluto affermare la prevalenza della regia sull’interpretazione, premiando due esecutori, una scarsa e l’altro ottimo. Non coloro che hanno saputo dare una propria firma ai film a cui hanno partecipato. Qualcuno avanza addirittura il sospetto (improbabile) che abbiano promosso gli interpreti che sarebbero potuti tornare a prendere il premio, visto che Landry Jones e Stone sarebbero stati impossibilitati causa sciopero.
Gli altri premi di Venezia 80
Politici i premi al pur bellissimo – per contenuti sorprendenti e “necessari”, non tanto per un linguaggio cinematografico convenzionale – Green Border (Premio speciale della giuria), a El Conde di Larraìn (in effetti la sceneggiatura è la cosa migliore di un film sgangherato) e il Leone d’Argento a Io, Capitano di Matteo Garrone, tra i suoi film meno riusciti, ma che si porta a casa pure il Mastroianni per Seydou Sarr tanto per ottenere la palma dell’opera più sopravvalutata di questo concorso. Sul tema, va detto senza ironia, ha detto più e meglio Checco Zalone in Tolo Tolo. Sia come contenuti, sia come linguaggio cinematografico e sceneggiatura. Il suo sembra più un premio alla carriera, che al film, così come quello al Pinochet vampiro di Larraìn.
Per lo meno il gran premio della giuria a Hamaguchi – Aki Wa Sonzai Shinai (Evil does not exist) – riconosce un lavoro tecnico e di adattamento e di pensiero di regia che da movimento diventa significato che è un esercizio sì di stile, ma di alta classe. Più come performance personale che come valore assoluto del film. È forse un rigurgito d’orgoglio per un concorso molto, troppo mainstream per una Mostra d’Arte.
D’altronde se Cannes rifiuta Netflix e tu la accogli, se sei la piattaforma di lancio per gli Oscar, diventi il festival più importante del mondo ma perdi un po’ in identità e capacità di scoperta. La quota sperimentale, allora, si rifugia in un gran premio della giuria che protegge la quota della ricerca e dell’audacia e nel non riconoscere il valore di Maestro, troppo Hollywood per gli autori europei tra i giurati.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma