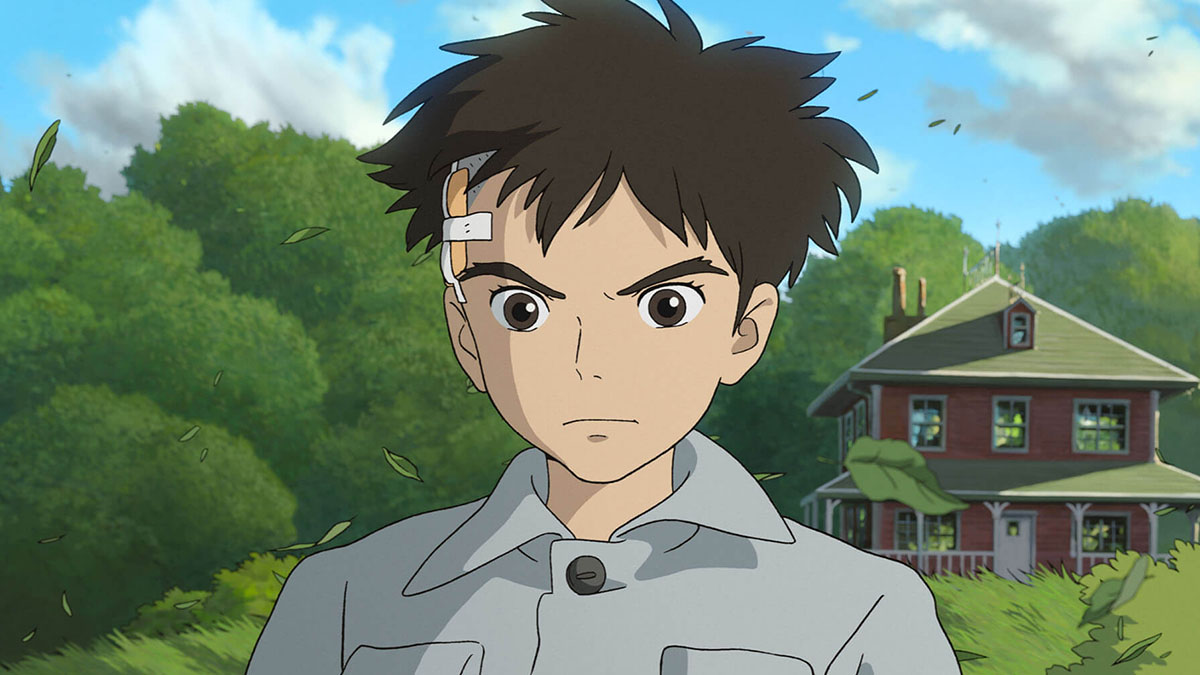A casa del ladro non si ruba, si dice. Ma per Gabriele Mainetti la tentazione era irresistibile. E così, mitigati gli effetti della pandemia sulle sale, il regista de Lo chiamavano Jeeg Robot – al lavoro da questa settimana sino a fine luglio sul suo nuovo film, sceneggiatura di Davide Serino – torna a scommettere sul suo progetto più difficile, il piccolo kolossal del 2021 Freaks Out, e sulla possibilità che possa conquistare un pubblico diverso da quello italiano.
Distribuito Da Rai Com negli Stati Uniti dal 28 aprile, col titolo Freaks Vs. The Reich, in cinque città (New York, Boston e Los Angeles le prime) e dallo scorso venerdì anche in Giappone (25 città, “con l’obiettivo – dicono da Rai Com – di arrivare a 30-35 in tutto il paese”), il film sui super-freaks di Mainetti si fa strada nei paesi che dei supereroi – in modalità diverse – hanno fatto una bandiera. “Mia nonna ha vissuto la prima parte della sua vita a Newark, mia sorella si è trasferita a Brooklyn e ho un nipote americano – racconta Mainetti, al cinema dall’8 giugno anche da produttore con Denti da squalo -. Io stesso, negli Stati Uniti, ho studiato regia. Ma l’università l’ho fatta in Italia, dove il cinema commerciale era demonizzato, come se fosse il male. Esisteva solo il cinema sofisticato europeo. Ma io con quei film ci ero cresciuto: sono stato forgiato da E.T.”
Freaks Out negli Stati Uniti: aspettative?
Freaks out è il mio film più “freak”, strano fin dal concepimento. Da una parte c’è una ricerca sulla messa in scena e sulla forma che segue le regole del kolossal americano. Dall’altra ha una natura più profonda, nel contenuto e nei personaggi, che è molto italiana. Avevo provato a fare lo stesso anche con Lo chiamavano Jeeg Robot, ma ci sono riuscito di meno. Gli americani dicevano che era “very grounded”, molto concreto. Speriamo dicano così anche di Freaks Out. Diciamo che per Jeeg avevo a disposizione un budget più contenuto. Con Freaks Out mi sono un po’allargato (circa 12 milioni di euro, ndr).
Pentito?
No, l’unico cruccio che mi rimane è che vorrei far uscire la versione integrale di Freaks Out, quella di tre ore. Ma mi costerebbe un altro milione di euro, e forse non è il caso.
Il terzo film: si ridimensiona?
Tra pochi giorni sono sul set, girerò fino alla fine di luglio, si spera. Salvo una delle mie solite sorprese (le riprese di Freaks Out si protrassero per più di un anno, ndr). Non mi ridimensiono, no. Ma sarò più sobrio. Non abbastanza sobrio da poter dire che girerò un “due camere e cucina”. Diciamo “qualche camera e qualche cucina”. Alla mia maniera.
E dal Giappone cosa si aspetta?
Il Giappone è un paese che mi vuole molto bene. Francia, Giappone e Germania sono i paesi dove piaccio di più. Freaks Out è stato venduto in tutto il mondo, ma del percorso in Giappone sono felicissimo: mi piange il cuore non poter andare, ma devo girare il nuovo film. Non sarò nemmeno a Cannes. Lo trovo un paese molto affascinante e in futuro mi piacerebbe lavorarci.
Cosa le piace?
La loro cultura, cosi antitetica a quella italiana, fondata sulla sobrietà del movimento. Da noi è tutto così sformato.
In Italia Freaks Out non è stato capito?
Allora: avendo studiato storia e critica del cinema, io la critica cinematografica la prendo molto seriamente. Per me è un faro. Ultimamente però mi sento molto più capito, e letto con entusiasmo, dalla critica giovane, che da quella, diciamo, più blasonata.
Ma lei è soddisfatto?
A me interessa sapere che ho fatto un film che è figlio della mia identità. Che non ho fatto compromessi. Ed è fondamentale che il film sia stato capito dal pubblico, non dalla critica. Freaks Out ha fatto il suo percorso: in teoria doveva uscire in sala, nel 2021, il 16 dicembre (invece andò alla Mostra di Venezia in concorso, ndr). Non è mai stato pensato come un film per i festival e le passerelle. Era nato per il pubblico. È arrivato in un periodo difficile e sì, credo si sia difeso.
Ha incassato abbastanza?
Gli è stato chiesto troppo, non poteva “riportare la gente in sala” dopo un anno e mezzo di pandemia. Era il mio “figlio” più strutturato e forte, ma ho sentito intorno a lui un certo malcontento. C’era un po’un’aria da, “ecco il secondo film di Mainetti, vediamo che fa”. A livello di comunicazione è uscito scarico, ma dopo il primo weekend ha moltiplicato gli incassi per quattro, con il passaparola. Era un film meno facile di Lo chiamavano Jeeg Robot, più adulto. Sa chi devo ringraziare? Gianni Morandi, che fece un post pazzesco su Instagram invitando la gente ad andare a vederlo.
Autocritica?
Non è un film perfetto. Penso, con la dovuta distanza, a Francis Ford Coppola che fa tre o quattro versioni di Apocalypse Now, o al maestro Sergio Leone con C’era una volta in America. Potrò sbagliare anche io qualcosa.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma