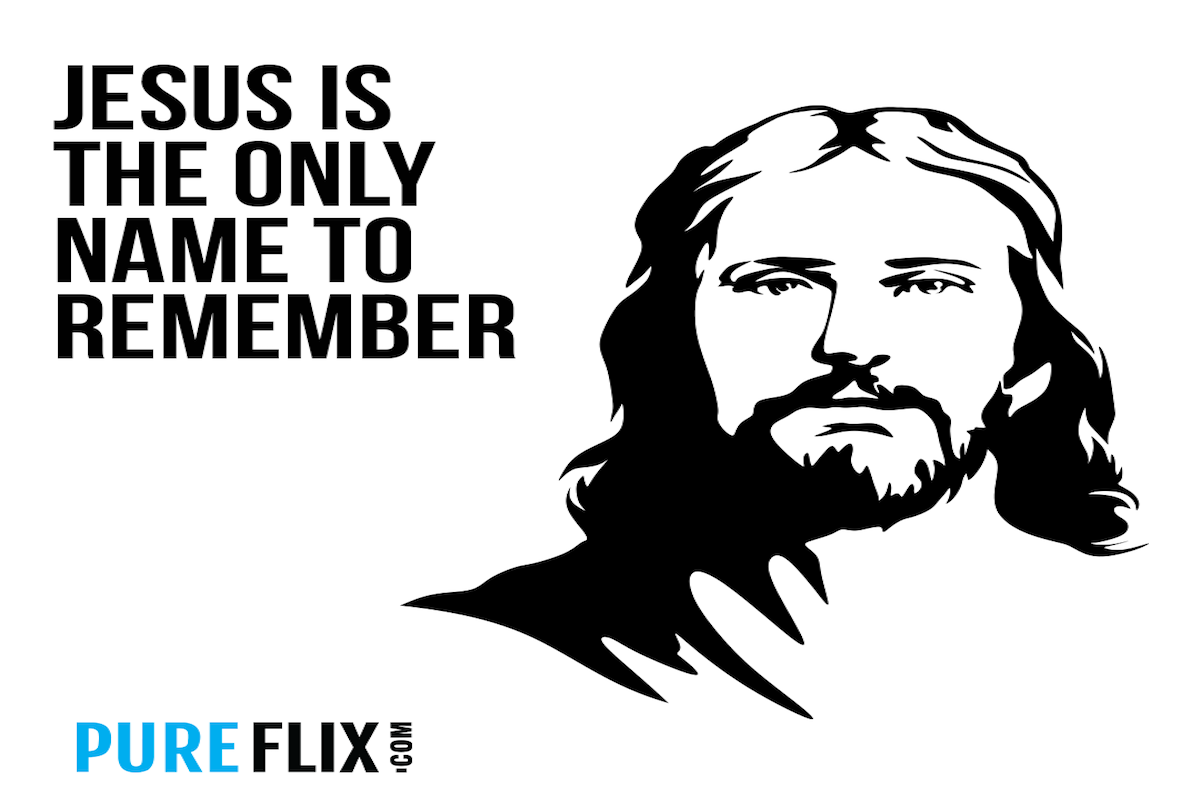Invelle, da nessuna parte. In nessun posto. Il film d’animazione firmato da Simone Massi è un creatura imponente. Un’opera di momenti che restituiscono un’immagine forte e allo stesso tempo sensibile dell’Italia rurale. Dell’oppressione fascista e nazista, e poi della liberazione, fino alle lotte operaie.
Un film autobiografico, in parte. E che tocca tantissimi argomenti in un soggetto che è stato scritto, come ha raccontato il regista Simone Massi a The Hollywood Reporter Roma, “dodici anni fa, di getto”. “Ho accumulato tantissime storie e quasi non riuscivo più a contenerle”, ha continuato il regista, “in un certo senso sono state le stesse storie a spingere per essere raccontate”.
Simone Massi, classe 1970, ha vinto il David di Donatello nel 2012 per il miglior cortometraggio, intitolato Dell’ammazzare il maiale, e quattro Nastri d’argento. Ora, dopo il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, è ad Alice nella città, sezione autonoma del Filmfest di Roma, con il suo primo lungometraggio, Invelle. Parola che nel dialetto marchigiano significa, appunto, “da nessuna parte” oppure “in nessun posto importante”.
Un film d’animazione con 40mila fotogrammi realizzati a mano e le voci di Toni Servillo, Neri Marcoré e Filippo Timi. Un tratto di disegno inquieto ma calzante per un’opera struggente e sentita. Nella recensione per THR Roma, Fabio Ferzetti ha definito Invelle “un lavoro monumentale”.

Simone Massi
Lei ha detto che il film è autobiografico, ma che ha anche i ricordi di sua nonna e di persone che non avevano niente a che vedere con lei. E anche un po’ di sogni. Quale sentimento l’ha spinta a raccontare questa storia? Era un progetto in mente da tempo?
Sono cresciuto in un’epoca e in un territorio in cui sopravviveva la tradizione del racconto orale: mi sono riempito di storie, incredibili, di gente comune: contadini, minatori, operai. Ne ho accumulate talmente tante da non riuscire più a contenerle. In un certo senso sono state le stesse storie a spingere per essere raccontate.
Il soggetto l’ho scritto di getto, dodici anni fa. Un arco di tempo che è sembrato interminabile, con problemi in serie e di tutti i tipi. Tutto questo ha generato confusione e una sfiducia che talvolta è diventata sconforto. Anche perché spesso cambiavano i referenti e ognuno aveva una propria visione delle cose, con un’attenzione rivolta più al pubblico che non al film.
Io non sono abituato a lavorare così, non ce la faccio. Poi fortunatamente è arrivato Salvatore Pecoraro e ha rimesso a posto le cose, siamo ripartiti dal film, dal mio modo di raccontare. Devo dirgli grazie perché è stato l’unico che mi ha dato piena fiducia e libertà assoluta. Su tutto, compreso l’utilizzo del dialetto.
Invelle è un film di ricerca sull’identità?
Invelle è un film che prosegue la ricerca cominciata nel 1997 e mai più abbandonata. Una ricerca che riguarda l’identità politica e culturale, le radici e la memoria.
Nel film traccia una linea interessante sulla funzione della scuola, da una parte come uno strumento di liberazione dai padroni e dall’altra come indottrinamento.
Non ho inventato niente, è andata esattamente a quel modo. Fino agli anni Sessanta i figli dei contadini non dovevano studiare e non studiavano. Chi era nato nel dopoguerra sapeva di non poter andare oltre la terza elementare. La mia generazione lo vedeva dalle firme dei genitori, in tutto e per tutto simili a quelle dei bambini. Rappresentavano comunque una conquista perché le generazioni precedenti firmavano con una croce.
Ho fatto una ricerca genealogica abbastanza approfondita e negli atti di nascita, battesimo, matrimonio e morte è un susseguirsi commovente di contadini e analfabeti, con figlioli che morivano come mosche. Una vita durissima, una marcia infinita e tragica che nessuna scuola si è mai presa la briga di insegnare. Ce l’hanno raccontato Ignazio Silone, Nuto Revelli, Danilo Dolci. E poi i vecchi, a chi ha avuto la fortuna e la curiosità di ascoltarli.
La scuola è indubbiamente una conquista. ma il paradosso è che nel momento in cui viene ottenuta i figli dei contadini smettono di essere tali. La scuola gli sputa addosso, gli impone di rinnegare la cultura e la lingua dei padri, di tagliare le radici.

Una scena di Invelle
Il dialetto gioca un ruolo fondamentale nella storia e nel racconto. Come è arrivato a questo risultato?
È frutto di trent’anni di ricerca, trent’anni spesi ad ascoltare e interrogare le generazioni precedenti, confrontando i vocaboli con quelli dei dialetti più vicini, umbri e aretini in particolare, cercando l’etimo e i riferimenti letterari.
Una ricerca che mi ha preso anni di vita e di sonno, sfociata in un volume di 700 pagine e capita da nessuno, nemmeno dai miei concittadini. Ma non mi pento di niente, ho imparato un mucchio di cose, su tutte il fatto che i contadini sono stati per secoli inconsapevoli custodi di un tesoro inestimabile.
La rozza lingua che faceva salire il sangue alla testa alle maestre e che veniva derisa da chi abitava in città era il volgare. La lingua di Dante e Boccaccio si era miracolosamente conservata sui monti, sui colli e nelle campagne. Grazie ai contadini.
Il cast vocale del film ha nomi importanti. Come è stato lavorare con questi attori e come si sono uniti al progetto? Ha qualche aneddoto?
Il film l’ho sempre immaginato con delle astrazioni, con degli stacchi narrativi. Sapevo, prima ancora di realizzarlo, che in certi punti sarebbe stato necessario abbandonare le vicende di questa famiglia contadina per prendere una pausa, il tempo di riposare, di ascoltare voci e canti che venivano da altrove.
Così entrano nella storia, e nelle storie, le letture di Celestini, Lo Cascio, Servillo, il canto di Giovanna Marini, la recitazione di Mimmo Cuticchio, il doppiaggio in dialetto pergolese di Timi, Baliani e Marcorè. Hanno aderito tutti con grande entusiasmo e generosità, sono stato contentissimo, al limite dell’incredulità. Dal canto mio ho cercato di spiegare quello che volevo con umiltà, spiegando che per me era la prima volta che ricorrevo al parlato e che a causa di questo preferivo farmi guidare da loro, dagli attori.
Mimmo Cuticchio è stato un fiume in piena, recitava la storia di Icaro alla sua maniera, improvvisando, cambiando ogni volta parole e sequenze. Ogni versione era diversa e memorabile, è stato molto difficile scegliere.
Filippo Timi è stato di una disponibilità eccezionale, versioni su versioni della stessa battuta, una più bella dell’altra. A un certo punto il fonico ha cominciato a protestare che Timi stava gridando troppo e se continuava in quel modo gli avrebbe spaccato il microfono. Filippo si è arrabbiato molto, temevo se ne andasse dalla studio di registrazione. In questo mi si permetta di citare anche i doppiatori meno noti, in particolare i bambini, perché hanno fatto un lavoro notevole.

Una scena di Invelle, di Simone Massi
Il film ha una connotazione politica molto forte, viene mostrata un’Italia in movimento. Che cambia, ma che in realtà sotto sotto non cambia. Cerca di dire che la prevaricazione muta faccia ma continua ad esserci?
Ho cercato di dire tante cose, più di tutto mi premeva raccontare di un mondo che ho fatto in tempo a vedere prima che morisse, un mondo fatto di persone prese a calci dalla Storia e che mi hanno fatto dono delle storie, frammenti delle loro vite. Oltre a questo nel film c’è ciò che da sempre sta intorno all’uomo, la guerra e la terra, le bestie e la scuola, il cielo e il mare.
Il tratto di disegno descrive perfettamente l’inquietudine della narrazione, come ha sviluppato questo stile? E quali sono state le sue ispirazioni?
È una tecnica che ho trovato poco meno di vent’anni fa e mai più abbandonata perché la trovo perfetta per il tipo di storie che racconto, per rendere i segni sulla pelle degli uomini. Consiste in pastelli ad olio stesi su carta e poi graffiati con sgorbie e puntesecche. Ho sempre cercato una tecnica che mi consentisse di avvicinare l’incisione, in particolare il segno di Bartolini e quello di Morandi.
L’animazione viene spesso sminuita come qualcosa per bambini…
Inizialmente mi dava fastidio, anche perché in altri paesi non è così, si sa distinguere e separare quello che è per i bambini e quello che invece non lo è. Vale per tutte le arti, disegnate e non. Per cui, quando ho cominciato a fare questo mestiere, non capivo perché l’animazione dovesse fare eccezione ed essere obbligatoriamente un prodotto per bambini, con pupazzetti colorati che per tutto il tempo saltano e fanno cose buffe.
Mi arrabbiavo perfino, e mi chiedevo i perché. Perché non si è chiesto a Giotto e Caravaggio di ridurre la loro arte alla caricatura? Nessuno sembrava essersi posto il problema. A me invece non stava bene per niente, avevo la necessità e l’urgenza di raccontare le storie nel mio modo. Oggi va un po’ meglio, a distanza di trent’anni sono un poco più calmo, mi arrabbio di meno.
Lei crede che l’animazione si stia ritagliando sempre più spazio nei festival nazionali e internazionali?
Ne sono fermamente convinto. I cambiamenti richiedono tempo, determinazione, pazienza, costanza, forza d’animo.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma