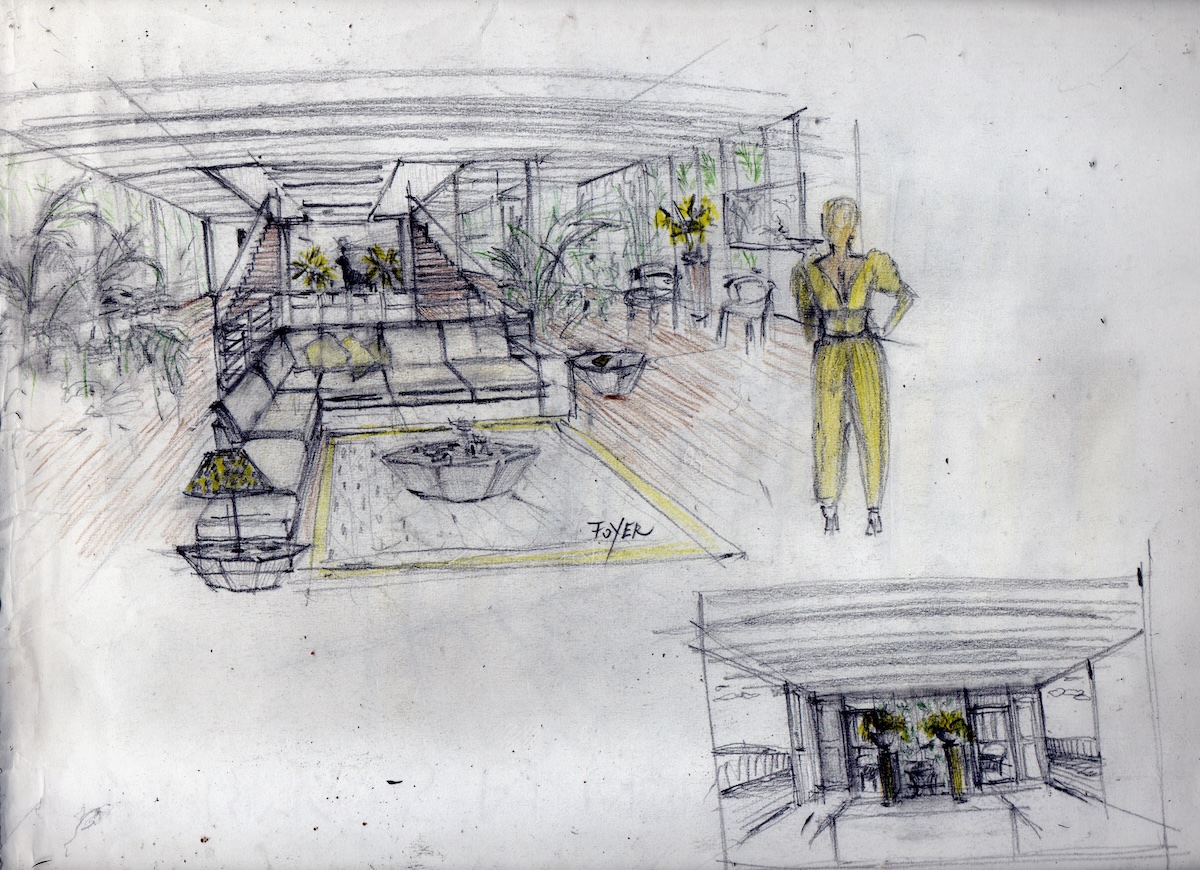Per vent’anni Cédric Kahn ha sentito nella sua testa la voce di Pierre Goldman, militante di sinistra che negli anni settanta fu protagonista di svariate rapine, al centro di un processo che lo incriminava per due brutali omicidi. Sebbene l’uomo riconoscesse molti dei suoi reati, si dichiarò sempre innocente di fronte all’accusa degli assassini. Ma ciò che contraddistinse l’intellettuale di Lione, ebreo di origine polacche, fu la sua arte oratoria e la capacità di portare la gente dalla propria parte.
È infatti dal suo libro (Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France) che è stato ispirato Kahn, un’arringa personale sulla propria non colpevolezza, che l’autore ha voluto poi mettere in scena nel 2023 con Il processo Goldman, presentato alla 76esima edizione del festival di Cannes, nella sezione Quinzaine des Réalisateurs. Opera passata in anteprima italiana al festival francese Rendez-Vous, dal 3 al 7 aprile. Una riflessione politica su un decennio passato, che comunica con impressionante (e inaspettata) lucidità col presente.
Cosa l’ha colpita della storia di Pierre Goldman?
Vent’anni fa ho letto il libro che ha scritto in cui parlava della sua detenzione, dei genitori, una sorta di arringa personale. Il testo mi colpì molto, mi ha intrigato la personalità di un uomo che ha portato avanti a spada tratta la propria auto-difesa e la cui ambiguità ha lasciato tante domande, sia prima che dopo il processo.
Processo che è il fulcro principale della pellicola.
Era il quadro migliore in cui descrivere un simile carattere. Volevo fare un film sulla parola. Non su di lui. Sulla parola. Sono rimasto affascinato dall’uso della dialettica di Goldman, il suo descrivere se stesso e il mondo esterno attraverso l’eloquio. Fin da subito ho capito che sarebbe stata questa la chiave con cui avrei voluto raccontare la storia.
E perché se aveva tutto chiaro ci sono voluti comunque vent’anni?
Ho continuato a rifletterci per tanto tempo. In effetti ero più volte sul punto di cominciare questa avventura, ma c’erano sempre difficoltà pratiche o non ero mai sicuro da qualche angolazione prendere un argomento come l’ebraismo, così ampio e articolato. Però mi è sempre rimasto in testa. Come se Goldman continuasse a ripetermi: “Non dimenticarti di me, non dimenticarti di me”. È il segnale migliore per fare un film. Non sono io che inseguo il soggetto, ma è il soggetto che continua a cercare me. È come ricevere una chiamata. Potrei quasi dire che è come se Goldman mi si fosse rivelato.
Come ha approfondito l’argomento? Ha attinto da materiale d’archivio?
Oltre al libro, mi sono basato sui giornali usciti all’epoca. Da lì ho ricreato tutto, in un connubio tra messinscena e realtà, che è poi il cuore della dialettica, e del cinema stesso. Saper rendere vero tutto ciò che è falso.
L’ebraismo, come da lei citato, è una questione centrale nel processo che riguardò Pierre Goldman. Il che rende l’argomento più attuale che mai. Come vive questo inaspettato, ma immediato collegamento col conflitto tra Israele e Palestina?
Non l’ho scelto. Non ho cercato di inseguire l’attualità. È successo. Il processo a Goldman è stato presentato in anteprima al festival di Cannes lo scorso anno ed è poi uscito nelle sale francesi una settimana prima il 7 ottobre 2023. Non ci sono collegamenti volontari con la realtà, anche perché ogni volta che il cinema cerca di inquadrare il presente, per forza di cose, quando arriva sullo schermo è già “passato”. Tra tempi di produzione, di riprese e distribuzione si arriva inevitabilmente in ritardo. È pur vero che il cinema ha i suoi tempi che determinano alcune coincidenze. Ma quando penso a un mio film non guardo mai al qui e ora, vorrei saper girare pellicole che puntino sulla lunga durata, e che risultino appetibili anche nel corso degli anni.
A proposito di coincidenze, nel film c’è un dialogo tra gli avvocati di Goldman che, a suo modo, si ricollega al discorso tanto contestato di Jonathan Glazer degli Oscar 2024. Un’altra coincidenza.
Nel film, ma anche negli scritti di suo pugno, il protagonista parla della sua identità ebraica e nel film viene spiegato cos’è Israele. Goldman dice una cosa importante: che vuole essere ricordato come un ebreo che vince, non una vittima. Per me questa è la definizione di Israele. E non bisogna confondere certo Israele con gli ebrei. Tant’è che sono d’accordo con Jonathan Glazer, il quale è stato molto chiaro sui suoi ideali. Ha ricordato di non etichettare chi ha qualcosa da ridire contro il governo israeliano come antisemita, e di stare attenti nel fare le dovute differenze.
È sempre questione di stare attenti alle parole che si pronunciano. Ma come si fa a dare ritmo a un film sulla parola?
La parola è uno strumento eccezionale da questo punto di vista. È un mezzo potente, pieno di forza, che può dare musica e espandere l’immaginazione. Conta però molto anche la recitazione, che in tal caso deve essere inappuntabile. La dialettica non funziona se non ci sono interpreti che non sanno reggerla. Devono saper essere intensi, tanto quanto le parole che pronunciano.
E come li ha scelti, dunque, i suoi di attori?
Abbiamo fatto un sacco di provini, eravamo in una sala molto grande così che si potesse sentire fin dove arrivava la loro voce, proprio come in un’aula di tribunale. Dopo che sono stati scelti, tutti dovevano imparare a memoria la sceneggiatura, non doveva esserci improvvisazione, bisognava conoscere per filo e per segno il copione. Non abbiamo avuto tempo di fare delle prove prima. Tutte le sequenze sono state girate nella loro lunghezza. Non c’erano stacchi e gli interpreti si trovavano ogni volta con una sala piena di pubblico, il che rendeva la recitazione una sfida, perché si dovevano confrontare con più di cento persone davanti. Questo li manteneva in allerta, mentre io potevo concentrarmi sul tenere in piedi l’arena. C’erano tre macchine da presa sul set ed erano sempre accese, così che gli interpreti sentissero costantemente gli occhi addosso e fossero costretti a continuare a recitare, anche se non sapevano o meno di essere ripresi.
L’intensità era inevitabile?
Un attore sa che deve essere molto più convinto e convincente quando si trova di fronte a tante persone, rispetto all’essere da solo con la macchina da presa. Ed essendoci in gioco la vita di un uomo, ognuno doveva sentire la necessità di imporsi sugli altri per far valere la propria idea.
Una competizione, insomma.
Sì. Così doveva essere. Una competizione sportiva. Dal film doveva trasparire una certa muscolarità. Ciò portava gli attori a dover essere quasi prepotenti tra di loro. Ho costruito il tribunale come fosse un match. Anche la regia richiama un cinema sportivo. Inoltre l’aula era stata ricostruita proprio su un campo da tennis.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma