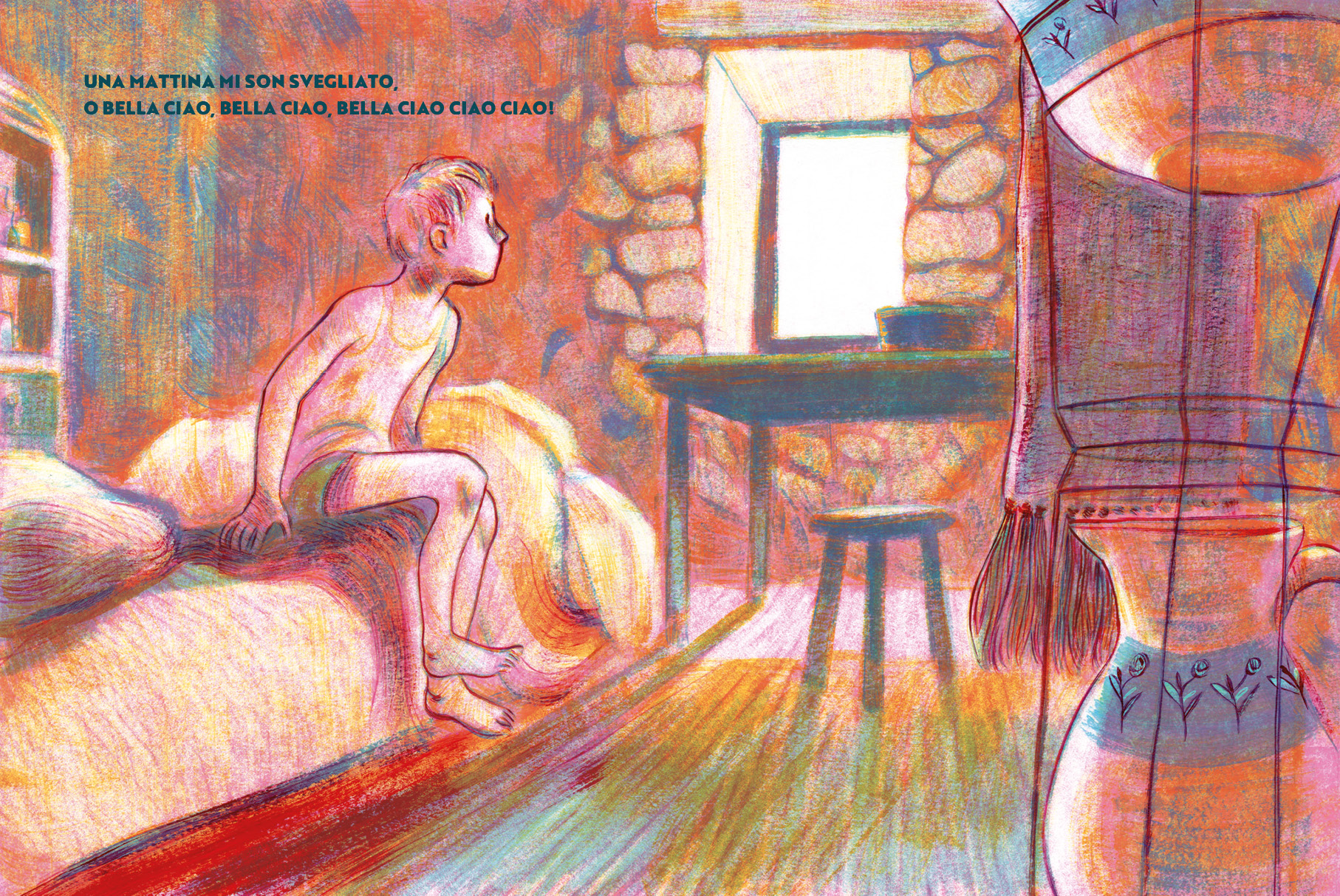C’è un piccolo evento: in rete e sì, nella bolla magari un po’ snob di chi legge, di chi ama andare a teatro, di chi va al cinema, di chi ha nostalgia di programmi capolavoro come Pickwick – Del leggere e dello scrivere (lo ritrovate su RaiPlay e non è invecchiato di un giorno, lui).
Non sarà un successo di massa, perché non siamo più negli anni ’90 in cui tutto sembrava possibile, perché sogni, capitalismo e un idealismo ancora appassionato ma anche disincantato ti dicevano che sì, potevi farcela se ci credevi abbastanza. In realtà la precarietà, la deregulation finanziaria e morale, la Guerra Calda delle multinazionali e dei fondamentalismi si stava mangiando già tutto ma noi non lo sapevamo e volavamo ancora. Soprattutto, volevamo ancora.
Ecco perché l’intervista, bellissima per tanti motivi diversi che proveremo a dirvi, di Matteo Caccia ad Alessandro Baricco, riscrive la grammatica dei podcast, perché pesca da quegli ultimi scampoli di Novecento il meglio, lo rincorre e lo fissa, prendendosi il (poco di) buono dalla modernità.
Non ha apparentemente schemi Wild Baricco – sì, alla fine capirete che la cosa meno riuscita è il titolo, ben più artificioso della chiacchierata – e invece è solo un’idea semplice, luminosa, che riflette sui recinti attuali e li destruttura.
Innanzitutto capisce ciò che capì Black Mirror delle piattaforme: senza pubblicità e palinsesti, diamine, i tempi puoi farli tu, dilatarli o stringerli. Puntate, stagioni, ritmi, li cadenzi come vuoi. E la narrazione, in un attimo, è più a suo agio, fuori dai 25 o 50 minuti, fregandosene di regole già morte.
Si può fare un podcast di una sola puntata che duri 126 minuti (anche se già sognamo Caccia che intervista Ammaniti o Lagioia o Carrere), un’intervista che più classica non si può, prendendosi uno spazio di riflessione senza fretta e, anche se l’intervistato ti ha detto “voglio dire tutto quello che non ho mai detto”, scegliere un sentiero di profondità e non di sensazionalismo, alla ricerca di contenuti, curiosità vere, di scoperta di chi si è tenuto sempre al riparo per far parlare la sua arte, e non di titoli, tweet, possibili viralità.
Wild Baricco, intanto, è bello per un motivo semplice. Matteo Caccia e Alessandro Baricco sono i migliori nelle loro categorie. Il primo non solo fa podcast straordinari, ma come pochi altri sa misurare tempi e parole e struttura narrativa su ogni argomento, come solo Pablo Trincia, con stile e angolazione diversa, sa fare.
Qui, per chi lo conosce, siamo un po’ dalla parte di Karim Franceschi, del suo capolavoro Oltre il confine. Qui Caccia, però, deve dare spazio a Baricco, il lavoro sul racconto è tutto dietro le quinte, di preparazione e domande, da passista dell’intervista, sempre attento alle opportunità che l’interlocutore gli lascia, in ascolto e pronto a piazzare un controcanto che apre un altro rivolo irrinunciabile, ma anche con una chiara idea di dove e come vuole arrivare. Oltre il confine era un puzzle da finire e spiegare, Baricco è una pietra pregiata da cesellare.
Lo scrittore piemontese è il prototipo dell’intellettuale moderno, ma nel senso più pasoliniano del termine (o, direbbe lui, fenogliano). L’artista torinese non può e non deve essere giudicato solo dai suoi libri – a proposito, Abel, il pretesto per questa lunga confessione, è sorprendentemente bellissimo e compiuto, mentre la sua bravura è spesso costruita da cicli che compiono la narrazione su più volumi – ma da tutto ciò che fa e ha fatto.
Dal teatro al cinema, dalla tv, e che tv, alla letteratura, dagli editoriali a questo Wild Baricco, dalla scuola Holden, la sua legacy più brillante e impavida, alla politica. Perché seppur reclama il diritto di non schierarsi, “perché conta il tono, il tempo, le parole e la forma di come dici le cose, non solo che siano giuste”, non si è mai rinchiuso in una torre d’avorio, ha accettato la sfida, pasoliniana appunto, di essere un intellettuale nel suo tempo e nel proprio paese (che pure non lo appassiona, ma poi la sua battaglia per la scuola è quasi patriottica) e in quanto tale con il diritto e dovere, visto il suo talento, di incidere con diverse forme di comunicazione.
Il suo io è sempre un noi, non rinuncia mai a migliorare ciò che vive e vede, fosse solo anche il nostro tempo mentre lo leggiamo. Il suo io è un noi e lo senti quando benedice di non essere stato e nato solo scrittore – “quella solitudine alla lunga fa male” – ma di aver avuto anche il talento di fare teatro e la scuola, di poter condividere il lavoro, di stare in una squadra. Molti che non lo hanno capito e i tanti che lo hanno copiato, hanno trasformato il noi in io.
Al di là delle ovvietà – essere i migliori aiuta, ma non è tutto -, il podcast in questione ha in sé qualcosa di prezioso. Matteo Caccia, scelto da Baricco, non recede, non rinuncia, non blandisce, ma appunto cesella, ritrae, ha l’ambizione quasi smisurata non di far dire al suo carismatico e ingombrante intervistato cose che non ha mai detto ma di fare qualcosa di ancor più spudorato e difficile: mostrarcelo come non si è mai mostrato, (ri)conoscerlo per la prima volta. Per questo la parola che ripete di più è “sputtanamento”, perché si rende subito conto che non rischia di svelare segreti, ma sta svelando se stesso.
Chi scrive è stato un adolescente baricchiano, affascinato dalla sua bellezza estetica ed etica, dall’arroganza che chiunque capisca di essere un elemento di rottura e di talento deve avere. In questo assomiglia in maniera quasi inquietante a Nanni Moretti, nel rivendicare un’antipatia che non è però mai mancanza ma forse eccesso di empatia per il mondo, un’empatia lucida e implacabile, che diventa arroganza solo perché gli altri non hanno il coraggio di vederlo, sbugiardarlo, restituirlo com’è davvero. Quell’antipatia anch’essa imitatissima, perché in troppi hanno pensato che bastasse essere dei bastardi per essere intellettuali, che bastasse tirarsela, per essere.
Poi, sempre chi scrive, è stato un giovane adulto convinto che da bella promessa Baricco fosse diventato arbasinianamente solito stronzo.
Il perché è facile. I baricchiani sono diventati barocchi e vecchi, rimanendo lui uno splendido trentenne. Loro hanno urlato cose sbagliate, lui si è ostinato a cercare la bellezza. Anche se ammette, l’essere stato odiato (ma pure adorato) da una massa (a)critica, aver inventato gli haters prima che esistessero, lo hanno peggiorato come persona, gli hanno tolto gentilezza ed eleganza. Ma aveva una battaglia, come Nanni, da combattere: demolire lo status quo, la mediocrità di premi, concorsi e salotti buoni (ha vinto un Campiello alla carriera, ma il suo trofeo è stato rifiutare il ruolo di giurato allo Strega), e si sa la guerra rende vittima anche chi vince, figuriamoci chi ha solo ragione.
Così, con miopia, era facile scambiare Alessandro Baricco per chi voleva essere Alessandro Baricco. Per chi lo leggeva e lo celebrava, senza capirlo. Per chi non ha ancora capito che la Holden non è una scuola di scrittura.
Baricco era diventato, come Bernstein in America, l’esempio e il simbolo del radical chic, perché lo erano i suoi adepti, non pochi allievi, troppi compagni di viaggio, esattamente come il buon Lenny non faceva troppa selezione all’entrata dei suoi party Vip per le Pantere Nere.
E un po’ lui si è cercato una comfort zone, almeno nei pulpiti, da Repubblica a ora, per questo podcast, Il Post (in collaborazione, quasi ovvia, con Feltrinelli), luogo di riflessione e di intelligenza che (anche) per questo è divenuto emblema di una certa classe socioculturale.
Baricco ha pagato chi l’ha imitato, chi ha reso la sua epica pop la possibilità di morire di retorica, chi ha tramutato il suo sguardo soggettivo e unico in un egocentrico io, chi ha scambiato per colloquiale e leggero ciò che in lui era studiato e rivoluzionario (Castelli di Rabbia è uno di quei romanzi dopo cui non sei più lo stesso), chi si è dimenticato la punteggiatura per indolenza e vezzo e non per inventare, trovare un nuovo linguaggio come lui.
Il dramma dei venerati maestri è capirsi prima degli altri, e lui lo è, ora, e sembra accorgersene verso la fine di questa intervista in cui ogni parola e riflessione sono oro, in cui è incredibile come danzi sui vocaboli, le pause (che punteggiatura raffinata ha, nel parlato), i pochi non detti e i molti detti così bene che ci rifletteremo per i giorni a venire.
Si mostra anche fragile quando parla dei corpi, della religiosità persa e in qualche modo sempre inseguita altrove, del pudico amore per Gloria, del rifugio trovato nel pianoforte per cui spese “tutti i soldi di Oceano Mare” (il denaro come veicolo di bellezza e conoscenza, che meraviglia anche se non fosse del tutto vero), nel ricordare che quando rientrava in albergo, dopo la tv, doveva “entrare dal retro”. “Per i fan?” chiede ingenuamente o maliziosamente, chissà, Caccia. E l’uomo che sa di essere bello e di essere stato il primo sapiosex symbol puntualizza, gongolando, “le fan”. Perché piacere non è un peccato, se sai che è effimero.
La scuola, Renzi, Fenoglio, l’amore, la malattia (solo sfiorata, ma è evidente che è stata un motore di molto, da Abel a queste parole) e poi ancora la gioventù scapigliata e arrabbiata, il sentirsi “lontano da tutti e da tutto” per troppo tempo, la meditazione, il suo modo di intendere la sinistra e la giustizia (per la prima, con poche parole ne restituisce tutto l’elitarismo classista che l’ha permeata, unita al fascismo di ideali alla moda) tutto contribuisce a un ritratto intimo e collettivo, che inquadra un uomo dallo straordinario talento ancora vivissimo ma che come prisma illumina e mette in discussione un’intera generazione.
Wild Baricco è anche emozionante – quando, con dolcezza, ammette che ha passato troppo tempo a litigare per ciò che riteneva importante, quando si rifiuta di leggere un passo de Il gorgo di Fenoglio, il suo faro -, è spesso divertente – “fino a 50 anni non sono mai stato lasciato, ma non è un vanto: semplicemente non davo loro il tempo di capire che testa di cazzo fossi” o “ho provato a curarmi dalla mia piemontesità, ho frequentato romani e milanesi, ma poi” -, ma soprattutto non è mai banale. Forse perché le tante cose che dice qui, a Caccia e a noi, per la prima volta le dice anche a se stesso.
E non sappiamo perché, ma il fatto che il podcast finisca con le parole “pasta al ragù” lo rende squisitamente perfetto.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma