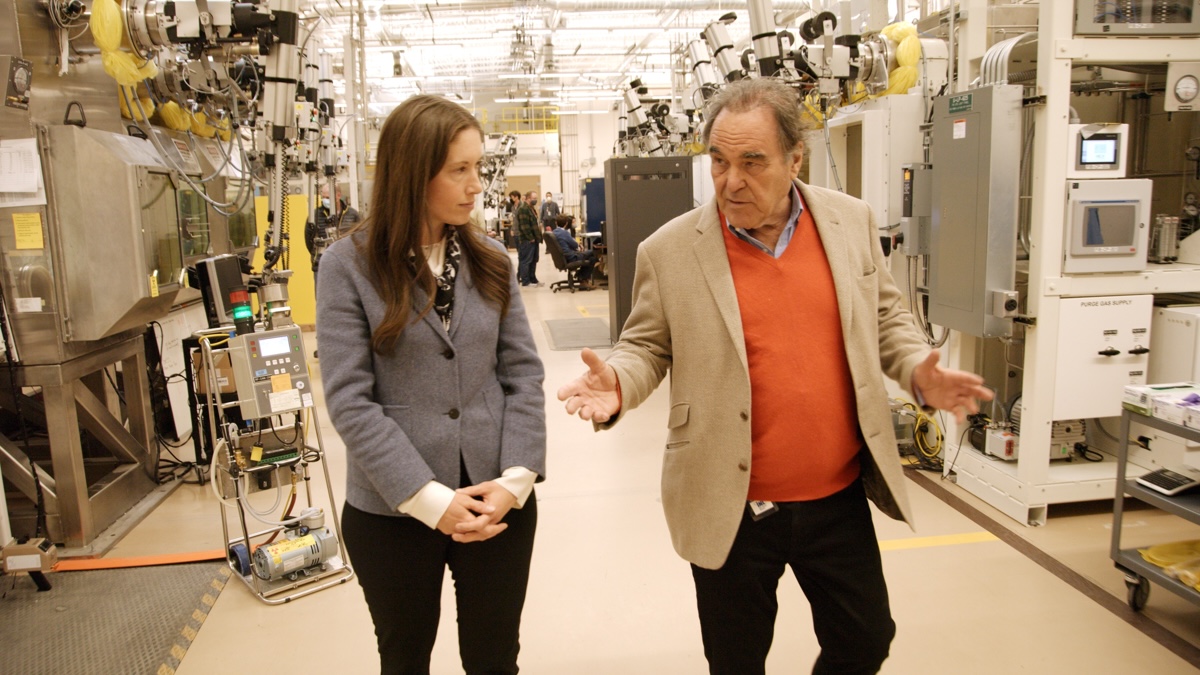“È un film che si svolge nel passato, ma parla del presente”. E mostra un talento destinato a fare la storia del cinema cileno. Felipe Gálvez, classe 1983 e un passato dal montatore, debutta al lungometraggio con Los Colonos, pellicola vincitrice del premio Fipresci a Cannes 76 e candidato cileno come miglior film internazionale alla 96ª edizione degli Oscar.
Una distribuzione Lucky Red in collaborazione con MUBI, dal 7 marzo in sala e dal 29 marzo sulla piattaforma ambientata all’inizio del XX secolo. Tre uomini a cavallo si imbarcano in una spedizione attraverso l’arcipelago della Terra del Fuoco per volere di un ricco proprietario terriero, incaricati di mettere in sicurezza la sua vasta proprietà statale. Ad accompagnare il tenente britannico e il mercenario americano c’è il meticcio Segundo, che si renderà conto, tra le crescenti tensioni all’interno del gruppo, che la loro vera missione è quella di “eliminare” la popolazione indigena.

Una scena di Los Colonos di Felipe Gálvez
La sensazione, guardando il film, è che le immagini siano come dei dipinti in movimento.
All’inizio volevo fare il film in bianco e nero. Ma poi ho pensato che non era una buona idea perché sarebbe sembrata una rappresentazione della realtà. Volevo apparisse come un documento storico di come erano andate le cose. A quel punto mi è venuto in mente di usare come riferimento la fotografia autocromatica, il primo esperimento di fotografia a colori. Foto dipinte, in pratica. Mi serviva per mostrare l’artificialità dell’immagine e lavorare su più linee. Il cinema stesso come immagine è artificiale e irrealistica.
Quando Simone D’Arcangelo, il direttore della fotografia, ha visto le immagini di riferimento, è stato molto felice perché ha avuto la possibilità di sperimentare con il colore. Per le scene notturne abbiamo utilizzato come riferimento la pittura di Frederic Remington. Per i massacri, invece, abbiamo guardato ai murales messicani. L’uso della macchina da presa, della fotografia e della pellicola cambia nel corso del film, non rimane statico.
Secondo lei, in che modo il suo film comunica con i nostri tempi? E perché ha scelto di raccontare questa storia con un western? Un genere tipicamente americano che, al suo esordio, era anche uno strumento di propaganda.
Penso che Los Colones sia un film che si svolge nel passato, ma parli del presente. La sceneggiatura è stata scritta riecheggiando situazioni che accadono oggi. E per quanto riguarda il western, proprio per quella sua natura propagandistica, mi piaceva l’idea di infiltrarmi nel genere. In altre parole, più che fare un western revisionista credo che l’esercizio sia stato quello di infiltrarsi e far credere alla gente di star guardando un western. E far sì che si confondessero pensando che stessimo esaltando i personaggi.
Ma nella storia dei colonialisti non c’è alcun eroe. Penso che il western sia un genere complicato, ma volevo usare i suoi codici, la sua musica, i suoi stili e, attraverso questi, criticarlo. Quando si è iniziato a mettere in discussione diverse figure storiche o molte ideologie politiche, mi è sembrato importante riflettere su quale fosse il ruolo del cinema. Cioè, da regista, piuttosto che restare fuori e guardare altro, mettere anche il cinema stesso sotto i riflettori. Per mostrare come abbia avuto la capacità, nel XX secolo, di distorcere e modificare la realtà partecipando alla riscrittura della storia. E anche questo mi è sembrato molto moderno. In altre parole, cambiano gli eroi, ma direi che il cinema di propaganda si fa ancora.

Una scena di Los Colonos di Felipe Gálvez
Quest’anno anche Martin Scorsese, con Killers of the Flower Moon, ha raccontato una storia di dominio e potere. Ha visto il film?
Sì, e naturalmente l’ho trovato interessante. Sembra che ci sia un’esplosione del genere in questo momento. In un articolo che ho letto è stato fatto un paragone tra il mio film e Killers of the Flower Moon. Credo che in entrambi ci sia qualcosa che riguarda chi è lo scrittore della storia. Chi è che la costruisce e chi è responsabile della cancellazione di alcune sue parti. In questo senso penso alla scena finale in cui compare lo stesso Scorsese. Credo che continueranno ad esserci molti altri film su questo argomento con nuovi punti di vista, più critici. Penso che i western del passato abbiano avuto solo un punto di vista critico nei confronti dei loro personaggi. Ma stanno uscendo più film che mettono in discussione il genere e il suo ruolo.
Molti registi cileni realizzano film politici. Secondo lei perché?
Prima di tutto credo che in Cile sia molto difficile fare film. È una contraddizione che abbiamo così tanti registi e così tanta esposizione rispetto ai fondi a disposizione e alle poche persone che li guardano. Credo, quindi, che ci sia una ricerca di temi interessanti. E probabilmente c’è anche una tradizione storica di registi cileni molto importanti che hanno fatto film politici. Il pubblico è interessato a vedere film del genere che dialogano con i problemi che accadono nel nostro Paese. Forse perché il Cile è costantemente politicizzato e abbiamo troppe questioni irrisolte. È un Paese che ha cancellato molte pagine della sua storia, dove si può parlare e discutere di tutto. Ma così come uno espone il problema, ci sono altri che si prendono la responsabilità di cancellarlo. Questo ci ha lasciato in eredità un debito: la necessità di recuperare la qualità del cinema.
La politica stessa ha influenzato il cinema cileno degli ultimi anni?
Bisogna anche capire che in Cile, durante la dittatura, non si facevano film. Le scuole di cinema sono rimaste chiuse quasi venticinque anni, per poi riaprire lentamente quando è tornata la democrazia. Credo che questo influisca anche su quello che vogliamo raccontare. Questa contraddizione del numero di registi e di film che hanno successo nel mondo, inoltre, ha un po’ a che fare con un modello altamente competitivo in cui vengono finanziati quattro film all’anno. Si lavora duramente e si ha molta paura di sbagliare quando si gira, di non poter fare un altra pellicola. Ogni volta che giriamo, è come se fosse il nostro ultimo film.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma