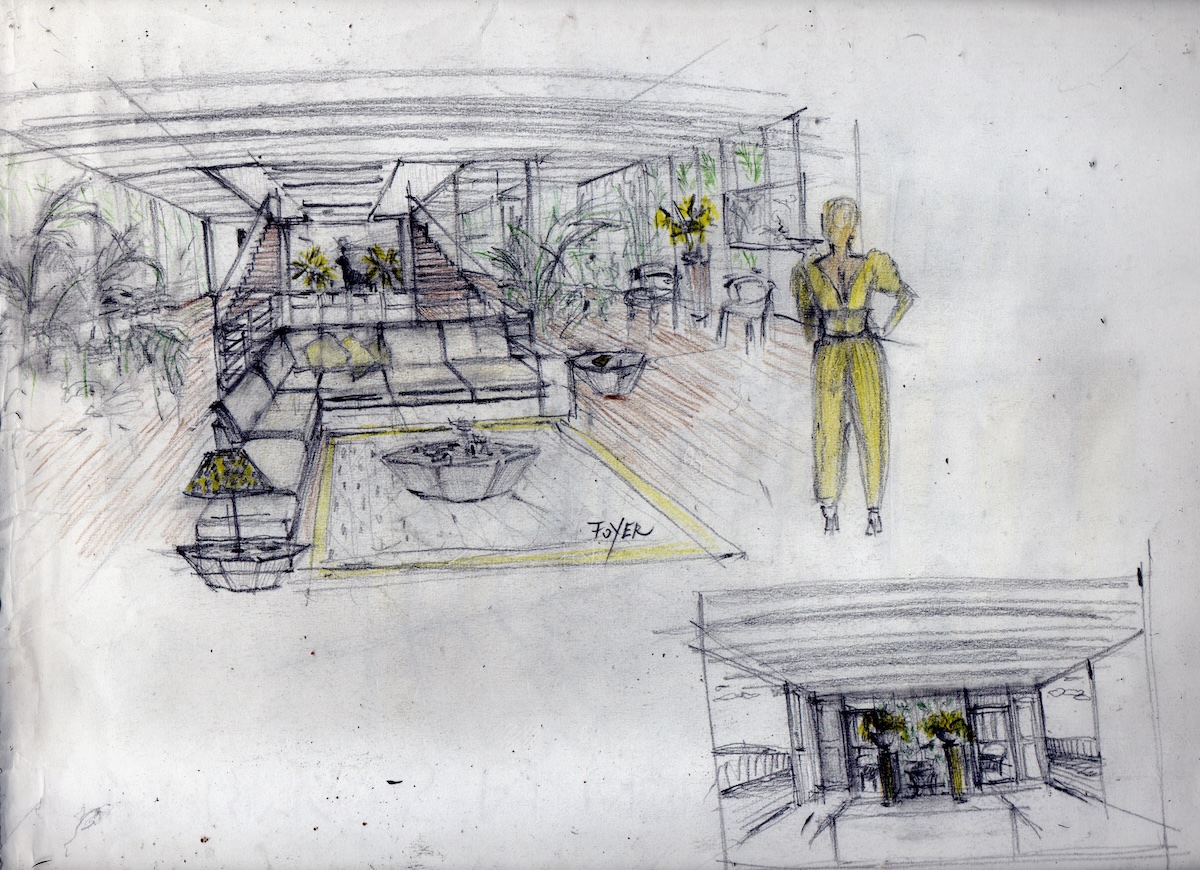“Ho finito, vero? Posso andarmene?”. Francesca Manieri, t-shirt blue con le maniche arrotolate, anfibi neri e pantaloni grigi, chiede all’ufficio stampa se quella appena fatta fosse la sua unica intervista in programma. Risposta negativa. Manca all’appello ancora THR Roma. Una risata collettiva prima di far partire il registratore. La sceneggiatrice, tra gli ospiti del Riviera International Film Festival, è stata protagonista insieme a Gaia Messerklinger di un incontro dedicato a Supersex, serie Netflix sulla vita di Rocco Siffredi.
Gay, attivista, femminista, Manieri sulla carta è agli antipodi rispetto al re del porno. Eppure proprio questa “lontananza” è stata l’elemento decisivo che ha permesso alla serie di prendere vita. “Ero una tutela a quello che veniva detto, perché la mia storia raccontava di un’altra appartenenza. Non è un mio titolo di merito, è un fatto che io porto”, sottolinea la sceneggiatrice. “Lo sapevo dal giorno uno, ma sapevo anche che la mia storia personale, oltre che la mia storia di autrice, sdoganava questa possibilità narrativa. Era un’opportunità di spostamento del racconto”.

Francesca Manieri, Gaia Messerklinger e Stefania Vitulli durante il panel su Supersex al RIFF 2024. Foto di Nicola Bottinelli
Come si fa a bilanciare la libertà espressiva con la macchina produttiva?
È faticoso. Sarebbe disonesto dire che non lo sia. Però sono abbastanza nota per essere una energica nella difesa delle proprie posizioni. Ma anche molto in ascolto, perché credo sinceramente in due cose. Una è che quando arriva una critica – anche da persone che non fanno questo mestiere – magari non hanno capito cosa non funziona, ma c’è qualcosa che non gira. Perché la narrazione è qualcosa che è dentro tutti noi. È un dispositivo talmente utilizzato e corroborato, che chiunque sa come si racconta una storia.
Un bambino, quando gli racconti una favola la prima cosa che ti dice, ogni volta che tu cambi qualcosa, è: “Non era così, ridimmela”. Il che vuol dire che c’è un modo di raccontare le cose che da subito entra nella psiche. In Occidente noi veniamo su da Omero in poi e quindi che cos’è un racconto, com’è fatta l’Iliade o l’Odissea, lo hai introiettato. Quando qualcuno ti fa una critica ha sempre ragione. Poi magari non sa dirti cosa, ma di base ha ragione.
La seconda cosa in cui crede, invece?
Ha a che fare con l’ingerenza del broadcaster. Lo dico sempre: non è che Michelangelo voleva fare Il giudizio universale o ha scelto la Cappella Sistina. Lo ha chiamato un Papa e gli ha detto: “Questo è lo spazio e questo è il tema”. Ma non è che Michelangelo rispondeva: “No, volevo fare la Marvel”. Magari ci avrà pure provato a dire: “Scusate, ma di giudizi universali è piena l’Italia. Non vogliamo fare una cosa un po’ più innovativa? Lo faccio uno con il mantello?”.
Non è che si esprime la libertà di Michelangelo nello stare dentro quel terreno, che è il terreno della produzione – in quel caso della committenza – per esprimere qualcosa che invece c’è di tuo dentro quel tema lì. E da un certo punto di vista più tu ti confronti con qualcosa che è mainstream, pop e che ha a che fare con dei codici, più manifesti la tua capacità o incapacità di dire qualcosa, di esprimere una libertà. Perché è solo dal limite che nasce la libertà espressiva, non al contrario.
In Anna, serie diretta da Niccolò Ammaniti tratta dal suo omonimo romanzo che avete adattato insieme per il piccolo schermo, la protagonista riceve dalla madre il quaderno delle cose importanti. Lei cosa ci scriverebbe su quel quaderno?
Una frase di Supersex: “Solo l’amore salva”.

Alessandro Borghi e Gaia Messerklinger in una scena di Supersex. Foto di Lucia Iuorio/Netflix © 2024
In questi mesi si è molto parlato di Francesca Manieri, gay, attivista e femminista, che racconta il re del porno. Pensa servisse questa distanza tra voi per poter realizzare un racconto che fosse diverso rispetto a quello che lo stesso Siffredi aveva fatto di sé in questi anni?
Ci sono due punti di vista da cui può servire. Uno è proprio becero e concreto. Questa è l’era del #MeToo, e quindi serve. Sarei disonesta a dire che questa intuizione qui è scevra da questa lungimiranza. Il margine di parola che il mio produttore e il broadcaster avrebbero potuto avere se non fossi stata io a scriverla sarebbe stata probabilmente minore. Ero una tutela a quello che veniva detto, perché la mia storia raccontava di un’altra appartenenza.
Non è un mio titolo di merito, è un fatto che io porto. Lo sapevo dal giorno uno, ma sapevo anche che la mia storia personale, oltre che la mia storia di autrice, sdoganava questa possibilità narrativa. Era un’opportunità di spostamento del racconto. Tant’è vero che la serie ha avuto un’inattesa e alta penetrazione sul pubblico femminile.
Valentina Nappi ha dichiarato a THR Roma che il porno è sempre politica e che il porno femminista la annoia.
Sono d’accordo con lei. Ormai ho una grande esperienza sul mondo del porno perché l’ho visto tantissimo. Lo vedevo anche prima, sono sincera, ma ora sono un’esperta (ride, ndr). E il post porno, che è andato forte un decennio fa, non è eccitante. Sarebbe interessante capire perché non lo sia, perché ci eccitiamo quando viene riproposto uno stilema abbastanza costante che ha a che fare con una certa stereotipizzazione dei ruoli di genere.
E sul fatto che il porno sia sempre politico è d’accordo?
Sì e no. L’analisi del porno è sempre politica proprio perché nasconde, contiene. E nonostante il nascondimento qualcosa eccede. L’elemento che è più politico di tutti per me, che è la sessualità, ha a che fare con qualcosa che è comunque il problema. In America puoi raccontare tutto in questo momento, ma non puoi raccontare il sesso e la sessualità. Questo dice qualcosa, no?
Con Supersex mette in scena il desiderio. Ma come si racconta sulla carta?
L’uso della voice over nella serie, un dispositivo che io tendo ad avversare quasi sempre, l’ho scelta per tante ragioni. La prima era creare una distanza critica tra ciò che vedevi e il livello di riflessione. Ho voluto che il pubblico fosse spiazzato da un livello che non era quello atteso. La seconda è che in alcune sequenze, tra cui quella in cui Rocco fa sesso con una prostituta transessuale, la voice over determina una chiara onda di desiderio. La parola cioè è super sessuale rispetto anche all’atto. Che lo è, ma in un altro modo.

Francesca Manieri
Con Luca Guadagnino avete parlato di adolescenti, sessualità, fluidità, ricerca di sé. Anche We Are Who We Are è una serie sul desiderio.
Non a caso in Supersex parto dai bambini e lì partivamo dagli adolescenti. La sessualità per me è quello che dice Freud: è “perverso polimorfo”. Supersex è una serie gay in cui gli uomini hanno desiderio e quel desiderio informa anche quello eterosessuale. Nella scena in cui Rocco fa sesso davanti a Gabriel Pontello la macchina da presa non inquadra la donna o l’atto, ma lui. Il desiderio cos’è? È lo sguardo ed è quindi la scrittura che deve segnare dove sta lo sguardo.
Perché il desiderio è quella intenzionalità che trasmette qualcosa di incomprensibile, inafferrabile, perversa e polimorfa che è la sessualità. Devi segnalare in scrittura cosa sta guardando il personaggio, spiazzato da cosa guarda e desidera. Per questo ho voluto la scena in cui Rocco viene toccato dalla maîtresse. In quel contatto immagina quello mai avuto con sua madre. Perché quella è la sessualità che va da tutte le parti e che origina dai luoghi più nascosti, che sono i luoghi della prima infanzia.
Parlando ancora di desiderio: ha visto Challengers?
L’ho visto sei volte (ride, ndr). L’ho visto senza musica e con la musica, all’anteprima romana, a Londra e Los Angeles. Un film sul desiderio e la repressione. Un film clamoroso con una regia incredibile che sta avendo in America un successo inimmaginabile. Lo reputano il film dell’anno. Se non è mai stato fatto un film sul tennis è perché il tennis è semi-irrappresentabile. Ma con lui quella partita diventa un atto sessuale. È una regia colossale. Luca è arrivato a un livello di maturità incredibile. Penso anche al suo prossimo film, Queer. L’ho visto in amicizia: è una cosa di una bellezza irragionevole.
Cosa prova per le sceneggiature che non diventano né film né serie tv. Come le vive? Sono dei fallimenti?
Il cimitero?
Lo chiama così perché è molto affollato?
Beh, sul mio computer oltre alla cartella con il titolo del progetto c’è anche la cartella “cimitero”. A volte ci sono le scene che hai sacrificato, a volte l’intero copione. Sulle sceneggiature che non diventano film ho imparato nel tempo che prima o poi hanno una loro vita. Mi dispiace solo di un copione che non è stato fatto, il primissimo che ho scritto. Non tanto perché l’avessi scritto io, ma perché era il copione di un gigante misconosciuto di questo paese: Peter Del Monte. Un regista che mi ha insegnato tantissimo. Non gliel’hanno prodotto. É l’unico tra i copioni non fatti che per me è ancora un dolore. Perché il nostro è un sistema ingrato e stupido che, a volte, penalizza moltissimo dei veri autori e invece fa credere a tutti di esserlo. Quando in realtà non ci sono.
C’è un libro che consiglierebbe a chiunque? Anche a chi non ne ha mai aperto uno.
È un libro che però non è un libro, ma che se leggi solo quello hai letto tutto quello che è stato scritto: Amleto. È una cosa fuori controllo, perché va da tutte le parti. Sono quelle che si chiamano opere mondo. Per me Amleto è l’opera mondo delle opere mondo.

Una scena di Supersex, serie Netflix scritta da Francesca Manieri. Netflix
È già stato detto e scritto tutto o l’importante è come quelle cose vengono dette e scritte?
Che è già stato detto tutto lo diceva Terenzio e sono passati millenni. Eppure la gente ha detto un sacco di altre cose dopo lui. È un’affermazione tautologica. Quando insegno parlo sempre dell’uso dell’archetipo. Recentemente ho fatto una masterclass all’Anica e ho detto che non si sa riconoscere qual è l’archetipo che sta dietro Baby Reindeer. È il mito Fedra e Ippolito, ma nel 2004. Solo che nel tempo qualcosa è successo nella relazione tra i due, rispetto ai codici culturali greci e latini.
Stai appoggiandoti su qualcosa che hai già visto ma ti sembra nuovo perché parla di oggi. E l’archetipo ha quella capacità di parlarti sempre di oggi se tu lo muovi bene. È un po’ complicato in questo momento, fai i progetti se hanno un concept forte. Quando hai una vastità di offerta, se hai qualcosa che cattura l’attenzione parti avvantaggiato non c’è dubbio. E questo è un limite oltre che un pregio. Dopodiché tutto sta nella capacità di raccontare le storie in un modo che è pertinente alla creazione di domande che riguardano la tua epoca.
Ma?
Il problema è che un certo tipo di broadcaster è costretto a darti un prodotto che non produce domanda ma produce consumo rapido.
Come il porno.
Sì. Sono meccanismi neoliberisti applicati al sistema dell’intrattenimento o al sistema para-culturale. La mia battaglia non è tanto dire: “Non faccio la serie su Rocco Siffredi”. Anzi, la faccio ma voglio un linguaggio alto, sette minuti di dialogo e un rapporto con il pubblico che non va necessariamente in binge watching. Voglio una serie che assomigli a un film per com’è costruita narrativamente.
In passato ha scritto anche Veloce come il vento, due capitoli della saga di Smetto quando voglio e L’incredibile storia dell’isola delle rose. Grande cinema pop che non viene riconosciuto quanto dovrebbe, però.
È una cazzata. Penso che Challengers sia un capolavoro, un film di intrattenimento. In America dicono che Guadagnino è il nuovo Ernst Lubitsch. Ma magari ce ne fossero. Ci sono voluti cinquant’anni per dire che Lubitsch era un genio perché il suo sembrava un cinema più leggero. Io vengo da una sala di provincia e lo so che cos’è il cinema. È un dispositivo popolare in primo luogo e come ogni dispositivo popolare va rispettato. E vale lo stesso per la serialità. A un film come Veloce come il vento si doveva dare un plauso per quel tentativo. Non è stato fatto.
Perché?
Il nostro è un sistema vecchio, molto sclerotizzato addosso a un certo tipo di immaginario di nuclei lobbistici di potere che non hanno riconosciuto dei grandissimi e delle grandissime autrici di questo Paese, nonostante siano stra-riconosciuti all’estero. Per me è una forma suicida.
Per chiudere: qual è la prima cosa che insegna ai suoi studenti?
Che la narrazione è un fatto etico e che quindi è un atto politico. E di non dimenticarselo mai.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma